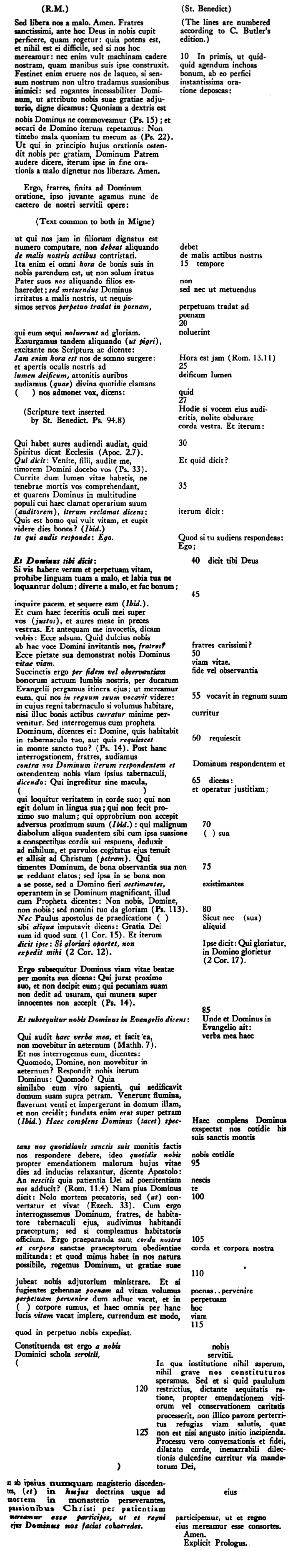
La Regula Magistri;
la primitiva Regola di San Benedetto
Di Odo J.
Zimmermann O.S.B.
Nel 1938 cominciarono ad apparire articoli
sulla Revue d'histoire ecclesiastique
riguardanti la Regula Magistri
[1]
e la Regola di San Benedetto. La discussione principale era incentrata sulla
dipendenza dell'una dall'altra. La questione è ancora in discussione e lo studio
più recente del problema è di Dom Cappuyns nelle
Recherches de théologie ancienne et médiévale
[2]. D. M. Cappuyns cerca di
provare che Cassiodoro è l'autore o il compilatore della cosiddetta
Regula Magistri e che dipende per il
suo materiale da una primitiva Regola di
San Benedetto.
Prima di lanciarsi in una discussione su
questo tema, è meglio richiamare alcuni argomenti riguardanti la RM. Essa è
stata generalmente considerata un commento alla Regola di San Benedetto. Un
recente studio, tuttavia, ha rivelato che potrebbe essere stata una fonte molto
importante per la regola di San Benedetto. Non è stata attribuita in modo
definitivo ad alcun autore conosciuto, né ad un periodo particolare, né a nessun
paese. C'è una notevole somiglianza tra questa e la Regola di San Benedetto.
Oltre alla stretta corrispondenza nel testo dei titoli dei capitoli, e spesso
anche nell'argomento dei capitoli, c'è una corrispondenza sconcertante del testo
del Prologo e dei primi sette capitoli della Regola di San Benedetto con i primi
dieci capitoli della RM. Sebbene quest'ultima sia molto più ampia e prolissa, è
molto sorprendente notare la grande quantità di materiale che è espresso con
identiche parole e frasi della Regola benedettina. "Stimiamo", dice Dom McCann,
"che questo materiale ammonti in tutto ad una decina di colonne della
Patrologia Latina di J.P. Migne
(Abbreviata in PL), vale a dire a circa un quarto della Regola di San Benedetto"
[3].
Per un comodo confronto di alcune sezioni
delle due Regole, vengono qui inseriti i seguenti passaggi paralleli contenuti
nei rispettivi Prologhi.
|
(P.L. 88. 943f)
Incipit Prologus
Regulae.
O homo, primo tibi qui legis,
deinde et tibi qui me auscultas dicentem, dimitte alia modo quae
cogitas; et me tibi loquentem, et per os meum Deum te convenientem
cognosce. Ad quem Dominum ex voluntate nostra per bona acta vel
beneplacita justitiae ire debemus: ne per negligentiam peccatorum inviti
rapiamur accersiti per mortem. Ergo, auditor, qui me audis dicentem,
percipe quae tibi, non os meum, sed per hanc scripturam loquitur Deus:
qui te, dum adhuc vivis, convenit de hoc quod ei post mortem redditurus
es rationem. Quia quod adhuc vivimus, ad inducias vivimus: cum nos
pietas Dei exspectat quotidie, emendari, et meliores vult esse nos hodie
quam fuimus heri. Ergo tu, qui me auscultas, ita attende, ut dicta mea
et auditus tuus per considerationem mentis ambulando in trivium cordis
tui perveniant. |
REGULA S. BENEDICTI
(Dom Cuthbert Butler
[4])
Incipit Prologus Regulae
Monasteriorum.
Obsculta, o fili, praecepta
magistri, et inclina aurem cordis tui, et admonitionem pii patris
libenter excipe et efficaciter comple, ut ad eum per oboedientiae
laborem redeas, a quo per inoboedientiae desidiam recesseras.
Ad te ergo nunc mihi sermo
dirigitur, quisquis abrenuntians propriis voluntatibus, Domino Christo
vero regi militaturus, oboedientiae fortissima atque praeclara arma
sumis. |
Il resto del Prologo della RM (43 righe di testo nella
PL) è qui omesso. Il Prologo è seguito da un
Thema, comprendente un commento al Padre nostro. Anche la prima
parte di questo Thema, che ammonta a
circa quattro colonne nella PL, è qui omessa. Ci uniremo di nuovo al
Magister nel suo commento al “sed
libera nos a malo”.
Nella sezione seguente quelle parti della
RM che sono identiche alla Regola di San Benedetto saranno riportate a sinistra
in doppio spazio, con le varianti testuali della Regola di San Benedetto a destra. Le parole
e le frasi della RM che non sono identiche a quelle della Regola di San Benedetto sono in
corsivo. Quelle che non si trovano in San Benedetto sono in corsivo e racchiuse
tra parentesi. Le parti omesse interamente nella Regola Benedettina sono
riportate in un unico spazio. Le parentesi aperte (…) indicano le aggiunte alla
RM
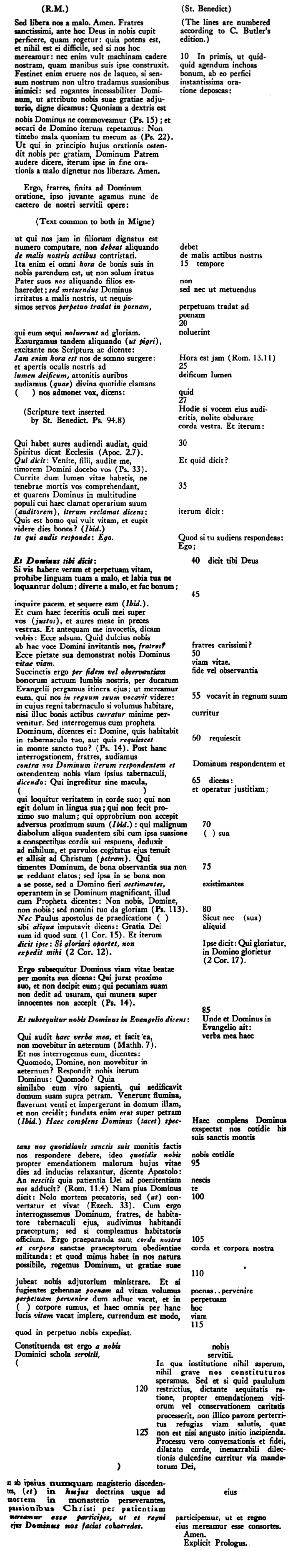
La somiglianza della RM osservata nel testo sopra
riportato permane in tutti i primi sette capitoli della Regola di San
Benedetto. Dopo di che troviamo meno corrispondenze nel testo, ma le molte
somiglianze sono ancora veramente sorprendenti. Il capitolo 8 di San Benedetto
trova il suo parallelo nel capitolo 33 della RM. I titoli sono identici:
De officiis divinis in noctibus. Il
capitolo 23 di San Benedetto ed il capitolo 12 della RM hanno ancora titoli
identici: De excommunicatione culparum.
Anche il contenuto è lo stesso, sebbene la formulazione sia leggermente diversa.
|
R.M. Capitolo 12.
In his omnibus
supradictis si quis frater contumax, aut superbus, aut murmurans, aut
inobediens praepositis suis frequenter exstiterit; et secundum divinam
praeceptionem semel, et secundo vel tertio, vel quovis vitio monitus et
correptus non emendaverit, referatur hoc a praepositis abbati: et qui
praeest secundum qualitatem vel meritum culpae perpenset, et tali eum
excommunicatione condemnet, ut sciat, qui Deum contemnit, quomodo dignus
est judicari per contemptum majori exhibitum; dicente ipso Domino
doctoribus nostris: Qui vos audit me audit; et qui vos spernit, me
spernit (Luc.
X) .
Quae excommunicatio tale habeat meritum. |
Regola di San
Benedetto Capitolo 23.
Si quis frater contumax aut
inoboediens aut superbus aut murmurans vel in aliquo contrarius
exsistens sanctae regulae et praeceptis seniorum suorum contemptor
repertus fuerit, hic secundum Domini nostri praeceptum admoneatur semel
et secundo secrete a senioribus suis.
Si non emendaverit,
obiurgetur publice coram omnibus. Si vero neque sic correxerit, si
intellegit qualis poena sit, excommunicationi subiaceat; sin autem
improbus est, vindictae corporali subdatur. |
Altri paragrafi sono stati completamente
modificati. A volte parti di più capitoli sono state fuse in uno solo. Frequenti
somiglianze con la regola di San Benedetto si trovano ovunque. Ciò è dimostrato
in particolare nei titoli dei capitoli.
Un esame molto superficiale dei due testi
mostra che se la RM è stata scritta per prima, San Benedetto deve essere
accusato di aver estratto in toto la parte più ispirata della sua Regola da
questa fonte. Come potrebbe allora San Gregorio Magno nel Secondo Libro dei
Dialoghi affermare che la Regola è un riflesso della vita e del carattere di San
Benedetto?
[5] Se possiamo provare che Cassiodoro
o qualsiasi altro scrittore successivo è l'autore della RM, allora San Benedetto
non può aver copiato dalla RM, e nessuno può privarlo in pratica di tutte le
pretese di originalità in un documento che è stato accolto attraverso i secoli
come il grande contributo personale di San Benedetto alla legislazione
monastica.
Se accettiamo gli argomenti di Cappuyns e
consideriamo Cassiodoro come l'autore od il compilatore della RM, allora
Cassiodoro è un semplice copista che prende alla lettera interi capitoli da San
Benedetto senza nemmeno riconoscere l'esistenza del Patriarca del monachesimo
occidentale. Ciò non sembra essere caratteristico del Cassiodoro che conosciamo.
Nelle sue Institutiones ed in altre
opere è normalmente molto coscienzioso nell'indicare le sue fonti. Perché non
dovrebbe riconoscere l'opera di San Benedetto, suo contemporaneo? Cappuyns fa di
tutto per sviluppare una ragione plausibile. Trova un altro caso in cui
Cassiodoro non menziona le sue fonti. Claudianus Mamertus, ad esempio, il
principale ispiratore del De Anima non
è menzionato perché, dice Cappuyns, Cassiodoro “di principio non parla dei
magistri novelli. Claudianus Mamertus
è senza dubbio uno di questi. A maggior ragione lo è San Benedetto”
[6],
e quindi non è menzionato da Cassiodoro. Quell'esempio non è parallelo perché,
anche se Mamertus ne ha fornito l'ispirazione, Cassiodoro ha scritto il
De Anima nel suo stile ed ha
sviluppato le idee a modo suo. Questo esempio non è quindi una spiegazione
soddisfacente per la reticenza del
Magister riguardo alla Regola di San Benedetto.
Inoltre, nel capitolo 1 della RM l'autore
fornisce un resoconto dettagliato della vita dei Girovaghi e dei Sarabaiti, con
i quali sembra aver avuto rapporti personali per un lungo periodo di tempo.
Parla come uno che ha fatto le sue osservazioni stando sulle porte di un
monastero, dove ha visto questi monaci vagabondi andare e venire, e descrive le
loro abitudini quotidiane di pigrizia, inganno e gola senza mezzi termini. È
probabile che Cassiodoro avesse avuto tali contatti con Girovaghi e Sarabaiti
nel suo monastero di Vivarium? L'immagine che lui stesso ci offre di Vivarium è
quella di un rifugio tranquillo e pacifico per i monaci letterati ed i santi
eremiti, lontano dalle volgari invasioni della "peggior specie di monaci", come
Cassiodoro dice nelle “Cassiodori
Senatoris Institutiones”. La descrizione dei Girovaghi e dei Sarabaiti
difficilmente può essere opera di Cassiodoro.
Dom Cappuyns, (nell’opera citata a pag.
266) afferma che Cassiodoro deve aver usato una forma primitiva della regola di
San Benedetto nella compilazione della RM. Ciò suona molto plausibile, perché il
testo da cui Cassiodoro ha preso a prestito evidentemente non conteneva alcuni
di quei bellissimi esempi di matura discrezione e moderazione come le righe 117
e segg. del Prologo. Cassiodoro, con il suo occhio per la bellezza ed il suo
apprezzamento per la qualità letteraria, ne avrebbe riconosciuto anche il merito
e, anche se non li avesse commentati come commentava altri grandi scritti,
almeno non avrebbe mancato di includerli nella sua propria compilazione della
RM.
Ora, se Cassiodoro ha copiato intere
sezioni da una precedente Regola di San Benedetto, ne consegue logicamente che
quelle sezioni della RM che corrispondono letteralmente alla Regola benedettina
sono la copia esatta di una primitiva Regola di San Benedetto.
Nel caso di citazioni che non si trovano
nell'attuale Regola di San Benedetto, non possiamo concludere che anche
Cassiodoro abbia copiato molte di queste dalla Regola primitiva? Abbiamo visto
sopra che difficilmente avrebbe potuto essere l'autore della descrizione dei
Girovaghi e dei Sarabaiti. Anche questa descrizione era nella Regola originale?
Non è stato ancora dimostrato, tuttavia,
che Cassiodoro sia realmente l'autore od il compilatore della RM. Quando
consideriamo lo stile della RM e lo confrontiamo con quello di Cassiodoro,
troviamo buoni motivi per non attribuirgliene la paternità.
La tabella seguente mostra i risultati
ottenuti dall'esame di 208 clausulae
(= Conclusione di un periodo o di una frase
[*])
della RM nella posizione finale. Gli esempi sono tratti da sezioni della RM che
non hanno nulla in comune con la Regola di San Benedetto o mostrano una grande
differenza nel modo in cui vengono espressi simili contenuti di pensiero.
[7]
Se Cassiodoro è l'autore della RM, allora la caratteristica del suo stile
dovrebbe apparire in quelle sezioni della RM dove è indipendente dalla Regola di
San Benedetto.
Per arrivare alle seguenti percentuali non
si è tenuto conto della normale tipologia
[8].
|
R.M.
Planus
32.2%
Velox
31.3%
Tardus
19.2%
Trispondaicus
4.8% |
Cassiodoro (Tutte le sue opere)
Planus
32.2%
Velox
27.6%
Tardus
25.1%
Trispondaicus
9.7% |
Nonostante queste somiglianze, ci sono due
variazioni significative. Nelle Variae
Cassiodoro osserva la seguente normale divisione delle parole nel 91,8% delle
occorrenze del planus:
arma / perducit o
arma / qui ducit. Anche nelle altre sue opere tiene in debita
considerazione questa normale tipologia nell'uso del
planus. La RM osserva questa divisione di parole nel
planus solo nel 59,7% delle sue
occorrenze nei 208 esempi trattati nella tabella sopra. Inoltre, in questi
esempi ci sono otto parole di cinque sillabe in posizione finale, mentre in
Cassiodoro "parole di più di quattro sillabe si trovano raramente in posizione
finale", secondo Sorella Mary Josephine Suelzer.
Un altro tratto caratteristico eccezionale
di Cassiodoro è il suo uso frequente di circonlocuzioni verbali come "probor
esse compulsus" o "provenire monstratur"
[9].
Nelle sue Institutiones compaiono 12
esempi in 57 righe di testo; nell'Expositio
in Psalmum, 13 esempi in 247 versi; nel
De Orthographia, 16 in 147 righe
[10].
In tutto, 41 esempi in 451 righe di testo. Un esame della RM, d'altra parte,
mostra che nel Prologo, Thema, Capitoli 1, 11, 12, 13 e 14 (pari a circa 1200
righe di testo nella PL) c'è solo un esempio (Cap. 1. 951C:
mentiri Deo per tonsuram noscuntur)
che può sicuramente essere classificato come una circonlocuzione di questo tipo.
Evidentemente questo tratto è estraneo alla RM
Cassiodoro, quindi, difficilmente può
essere l'autore od il compilatore della RM. Gli argomenti esposti da Dom
Cappuyns, tuttavia, suggeriscono un'altra soluzione che è allo stesso tempo
semplice e plausibile, vale a dire che l'intera RM è la primitiva Regola di San
Benedetto.
Nella stessa frase di apertura della
presente Santa Regola, San Benedetto si definisce
magister. Obsculta, o fili,
praecepta magistri. Ciò non è necessariamente un'arrogante affermazione da
parte sua, poiché esprime semplicemente la relazione naturale che esiste tra lui
ed i suoi monaci. Anche i titoli dei capitoli della RM mostrano questo tipo di
relazione. Appaiono regolarmente nella seguente forma:
Interrogatio discipuli. Qualis debeat esse abbas? Rispondi Dominus per
magistrum.
San Gregorio nella sua vita di San
Benedetto lo chiama magister in
diverse occasioni e usa spesso il termine
discipulus per un monaco.
[11] Ciò sembra dimostrare che il
rapporto di magister e
discipulus tra San Benedetto ed i suoi
monaci fosse dato per scontato da San Gregorio
Genestout, Alamo e Cavanera sostengono con
forza la priorità della RM. Capelle e Cappuyns
[12]
hanno già suggerito che la RM contiene almeno parti di una primitiva Regola di
San Benedetto. Il passo successivo è considerare l'intera RM come l'opera
giovanile di San Benedetto ed accettarla, così com'è, con la sua estensione e
prolissità, come l'esuberante legislazione dell'uomo giovane ed inesperto che il
patriarca maturo ed esperto ha rivisto e modificato nel codice conciso e pratico
che abbiamo oggi.
Questo approccio offre una soluzione
naturale e plausibile a molti, se non a tutti, i problemi e le difficoltà
riguardanti l'interrelazione di questi due documenti. Non sarà più necessario
inventare scuse inverosimili per Cassiodoro o l'incertus
auctor, né supporre che uno di loro sia stato soggetto ai capricci di una
mentalità distorta. Se la RM è opera di San Benedetto, l'intero problema
dell'originalità e delle fonti non riconosciute è risolto.
Quindi, possiamo anche
spiegare perché una regola così lunga e dettagliata per i monaci, come la RM,
avrebbe dovuto essere conservata per noi senza lasciare traccia del suo
effettivo utilizzo in un qualsiasi monastero durante un periodo lungo ed attivo
della storia monastica. È naturale che la RM sia passata in disuso dopo essere
stata sostituita dall'attuale Regola di San Benedetto. Ma ci devono essere state
delle copie di essa, poiché era in uso fino all'introduzione della Regola
riveduta.
Si può anche determinare il suo luogo di
origine, ovvero Subiaco
[13].
Tutti gli episodi riportati nella RM sembrano rientrare nello scenario di
Subiaco, come possiamo raffigurarlo dalle indicazioni della Santa Regola e dalla
descrizione data da San Gregorio Magno. San Benedetto, da giovane, guadagnò una
reputazione di santità ed austerità. La sua fama attirò l'attenzione ed in molti
si recarono da lui: i buoni, i cattivi e gli indifferenti. Si misero sotto la
sua guida e lui diventò il loro magister.
Costruì monasteri per alcuni, ad altri permise di vivere da eremiti.
Esaminiamo ora la descrizione dei Girovaghi
che ci fornisce la RM. Alcuni brani del relativo Primo Capitolo (PL vol. 88,
col. 951C-953B) recitano come segue:
13 La quarta specie di monaci, — non si dovrebbe
neppure nominarla ed io farei meglio a passarla sotto silenzio piuttosto che
parlare di gente simile, — 14 la si chiama la specie dei girovaghi. Tutta la
loro vita, vagando nelle varie province, si fanno accogliere tre o quattro
giorni nelle celle e nei monasteri dei vari monaci. 15 Così, pur volendo essere
ricevuti ogni giorno di nuovo da gente diversa, come si addice all'arrivo di un
ospite, 16 e pur costringendo ogni giorno degli ospiti vari, per il piacere del
loro arrivo, a preparare loro cibi scelti e ad uccidere col coltello, in onore
del loro arrivo, animali di cortile, 17 essi non credono, in tal modo, di essere
a carico di queste varie persone, poiché, cambiando ospite tutti i giorni, si
fanno preparare da varia gente piatti diversi, come si conviene all'arrivo di un
nuovo arrivato, sotto la forma di una carità importuna. 18 E quando, come se
fosse malgrado loro, esigono da ospiti diversi il compimento del precetto
dell'Apostolo, nel quale egli dice: «Siate premurosi nell'ospitalità (Rm
12,13)», 19 quando, prendendo a pretesto questo precetto richiedono, dopo il
cammino, cure per i loro piedi senza riposo ma, col pretesto del viaggio sono,
molto più dei loro piedi, le loro viscere sporcate da una cena o un pranzo
troppo generosi che desiderano curare con bicchieri colmi senza fine. .........
24 Ed immediatamente interrogano per sapere dove si trova un monaco o un
monastero nella vicinanza, per fare sosta e per fermarsi quando avranno lasciato
questi luoghi,
........31 E quando, dopo due giorni passati presso lo
stesso ospite, le ricercatezze culinarie iniziano a diminuire e scomparire 32 e
la mattina del giorno dopo vedono l'ospite occupato, non a cucinare il pasto, ma
ai lavori della propria celletta, immediatamente pensano bene di cercarsi un
ospite altrove. Non appena arrivati, ecco che ripartono! 34 Allora si affrettano
di dire addio a quest'ospite diventato avaro e, nella rapidità che hanno di
scappare da questo alloggio, chiedono all'ospite di fare una preghiera per la
loro partenza. 35 Si affrettano come se fossero spinti, come se già li
attendessero dei pranzi già pronti presso altri ospiti.
36 E se, a poca distanza di questo monastero, trovano
una celletta di monaco, si riposano dicendo che arrivano da oltre i confini
dell'Italia
[14]. 37 E, con la testa inclinata in segno
d'umiltà, ripetono a quest'ospite qualche storia menzognera di pellegrinaggio o
di schiavitù, 38 obbligando il loro amorevole ospite, per pietà per questo lungo
viaggio, a svuotare tutta la sua povertà nelle pentole e sulla tavola.
Questa descrizione dei Girovaghi si
inserisce facilmente nel quadro di Subiaco. Questi monaci vagabondi si fermavano
nei monasteri che San Benedetto vi aveva costruito ed anche nelle case degli
eremiti. Abusavano dell'ospitalità di ciascuno a turno. Il loro modo di vivere
diventò di conoscenza comune. In effetti, i singoli Girovaghi sono praticamente
identificati dalle loro parole ed abitudini. Quando San Benedetto visita i
monasteri o contatta gli eremiti, raccoglie l'intera storia della vita
e del carattere
ingannevole dei Girovaghi. La sua descrizione di essi potrebbe
quindi facilmente includere i dettagli forniti nella RM, poiché sembrano
mostrare che l'autore fosse in contatto con i monasteri e con i singoli monaci
che gli hanno raccontato le proprie esperienze. Chi, allora, avrebbe potuto dare
questa descrizione meglio di San Benedetto stesso?
Si possono anche spiegare le differenze
psicologiche tra la RM e la Regola di San Benedetto. La prima è naturalmente
immatura e mostra lo zelo di un uomo più giovane che è interessato e preoccupato
per i particolari e le minuzie. Ciò è evidente in tutta la RM. Nella redazione
finale, tuttavia, la maggior parte dei dettagli sono riassunti in poche frasi o
minimizzati con una o due parole. Più spesso i dettagli vengono semplicemente
omessi. Ma la stessa caratteristica di fornire dettagli minuti è comune in tutti
i capitoli della RM. Ad esempio, il Capitolo 26,
De mensura ciborum, è ridotto a poco
più della metà della sua lunghezza originale nel Capitolo 39 dell'attuale regola
di San Benedetto. Il Capitolo 11 della RM,
De praepositis monasterii, subisce un cambiamento simile nel Capitolo 21 di
San Benedetto. Il Capitolo 81 (RM), De
vestimentis, è riassunto da San Benedetto in una dichiarazione generale e
sono conservati solo i dettagli necessari.
Nel confronto totale dei due testi
troviamo lo stesso tipo di revisione: i dettagli in eccesso vengono eliminati o
riassunti e codificati in leggi generali, ma le idee principali rimangono le
stesse. La frase della RM (C. 26) “Medius
panis pensans libram singulis fratribus in die sufficiat”, diventa “Panis
libra una propensa sufficiat in die” (C. 39). Il Capitolo 83 della RM,
Quomodo debent haberi in monasterio
sacerdotes, è reciso dei suoi dettagli nel Capitolo 60 della Regola di San
Benedetto, De sacerdotibus qui forte
voluerint in monasterio habitare. Sebbene la formulazione dei due capitoli
sia diversa, lo spirito è lo stesso: il sacerdote è onorato e rispettato, ma
deve essere soggetto alla Regola.
In generale la presente Regola di San
Benedetto mostra una maggiore maturità ed un giudizio più solido rispetto alla
RM. Esprime i principi generali dedotti dai dettagli descrittivi del testo della
RM. Ciò mostra chiaramente la sua crescita costante ed il suo sviluppo naturale
rispetto alla RM
Se
nella RM confrontiamo il capitolo 10 sull'umiltà con il capitolo 7 di San Benedetto sulla stessa virtù, troviamo
ulteriori prove che confermano la paternità comune. Il capitolo 7 (sull'umiltà)
è così caratteristico di San Benedetto che nessuno dubita della sua paternità.
"Perciò il VII capitolo è ritenuto giustamente come la finale espressione della
spiritualità monastica"
[15],
non può essere opera di nessuno tranne che di San Benedetto. Sappiamo che ne ha
preso in prestito l'intera struttura da Cassiano. Ma san Benedetto cambiò
l'ordine dei gradi di umiltà e, inoltre, ampliò notevolmente il breve riassunto
di Cassiano.
Ma questo capitolo si trova letteralmente
nella RM, con solo lievi variazioni nelle singole parole o frasi. L'autore del
capitolo sull'umiltà deve essere lo stesso nella RM e nella Regola di San
Benedetto. Ma nella RM questo capitolo contiene sezioni che non sono contenute
nella presente Regola di San Benedetto. Costituiscono una parte così naturale
dell'intero capitolo, tuttavia, che siamo costretti a concludere che l'intero
capitolo 10 della RM è stato messo insieme da San Benedetto e che ne ha omesso
parti nella sua stesura finale. Se dunque san Benedetto è l'autore di tutto
questo capitolo della RM
[16],
cosa ci impedisce di concludere che abbia scritto tutta la prima sezione della
RM, dal Prologo al capitolo 10 compreso?
Dal breve paragrafo alla fine del capitolo
10 della RM, (“Qui finisce l’attività della milizia del cuore: come si fuggono i
peccati per il timore di Dio”) sappiamo che i primi dieci capitoli formano
un'unità a sé stante. C'è una base, quindi, per dire che questa sezione è forse
l'unica parte della RM che San Benedetto ha scritto e che non è l'autore degli
85 capitoli che rimangono. Ma un esame della sezione successiva della RM
indicherà il contrario. Dobbiamo solo esaminare i titoli dei capitoli per vedere
la loro somiglianza con quelli di San Benedetto. Alcuni sono stati predisposti
per un comodo confronto.
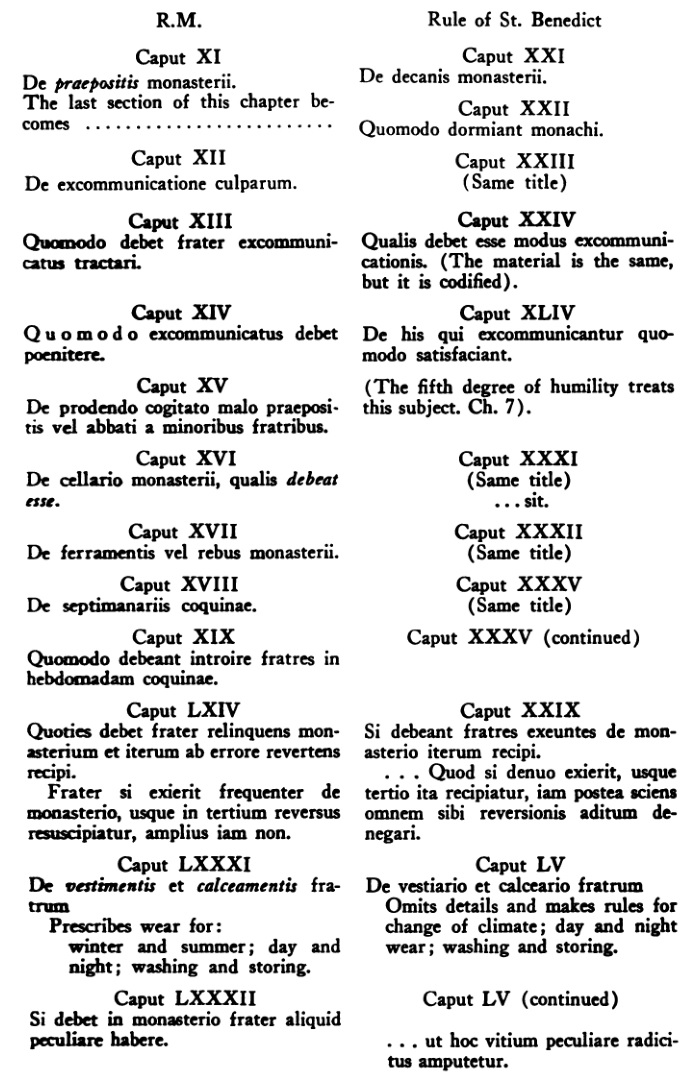
La somiglianza e la corrispondenza delle
frasi continuano in tutta la RM. Quasi ogni intestazione di capitolo della
Regola di San Benedetto ha un'intestazione corrispondente nella RM. E la
corrispondenza dei titoli dei capitoli da sola è un argomento forte per la
paternità comune. Oltre a questo ci sono grandi somiglianze nel contenuto di un
certo numero di capitoli. Capitolo 12 (RM) e Capitolo 23 (San Benedetto);
Capitoli 64 e 29; Capitoli 81 e 55. Un gran numero di frasi è identico in
entrambi i testi. Dom McCann, nell’opera citata, sottolinea la presenza di
queste parole “benedettine” nella RM. L'identità di queste non può essere
spiegata in modo soddisfacente se non si accetta San Benedetto come l'autore di
entrambe le Regole. Che una notevole identità di testo si estenda solo ai primi
dieci capitoli della RM sembra indicare che questa sezione fosse già stata
sottoposta ad una revisione per mano di S. Benedetto. È la sezione che contiene
gli elementi essenziali della spiritualità monastica o, nelle parole di chiusura
del capitolo 10 del testo della RM, l’actus militiae cordis (L’attività della milizia del cuore).
La severità della sezione successiva della
RM in alcune delle sue leggi non è in contrasto con il carattere di San
Benedetto ,come ce lo delinea San Gregorio Magno. Quante volte San Benedetto
viene raffigurato mentre rimprovera severamente i monaci per infrazioni che
potremmo facilmente considerare piuttosto lievi? Ad esempio, il monaco che ha
accettato alcuni fazzoletti in segno di ringraziamento dalle suore (Dial.,
II, 19); i fratelli che hanno cenato sulla via del ritorno al monastero (Dial.,
II, 12); il fratello di Valentiniano che ha rotto il digiuno mentre si recava al
monastero (Dial., II, 13). Queste
severità riflettono la legislazione della RM al Capitolo 82,
Si debet in monasterio frater aliquid
peculiare habere, può facilmente spiegare la storia dei fazzoletti. Gli
altri due incidenti possono essere spiegati sulla base di tre capitoli che
trattano minuziosamente la questione del mangiare e del digiuno durante il
viaggio: Capitolo 59, Qua hora debent
fratres in via reficere; Capitolo 62,
Si debet extra horam consitutam in via frater aut manducare aut bibere; e il
capitolo 61, che tratta esplicitamente della questione del mangiare fuori dal
monastero su invito di altri. La prescrizione vale per i monaci, ma può anche
spiegare la severità di San Benedetto con il fratello di Valentiniano.
Nel capitolo 33 del Libro II dei Dialoghi,
San Gregorio descrive l'ultimo incontro tra San Benedetto e sua sorella, Santa
Scolastica. Supplica il suo santo fratello di restare tutta la notte a parlare
con lei delle gioie della vita eterna - ut
usque mane de coelestis vitae gaudiis loquamur. Nella RM ci sono due
descrizioni vivide ed interessanti delle gioie del cielo (Nel finale dei Capitoli
3 e 10). L'autore della RM e San Benedetto avevano evidentemente questo
interesse in comune.
Il capitolo 70 della RM,
De charitate fratrum circa aegrotos, è
molto caratteristico di San Benedetto. Così stabilisce questo capitolo: “I
fratelli che desiderano mostrare la pienezza della loro carità si superino a
vicenda visitando i fratelli malati, consolandoli e servendoli; affinché la
carità trovi la sua prova nel momento del bisogno, quando i fratelli mettono in
pratica le parole del Signore: "Ero malato e mi hai visitato".
Il buon giudizio e la discrezione che si
trovano nella RM sono stati spesso ignorati nel passato. Un esame del testo
mostrerà che la quantità di legislazione eccessiva o scriteriata è relativamente
piccola. Gli esempi standard messi chiaramente in evidenza ogni volta che viene
menzionata la RM sono il capitolo 13, Quomodo debeat frater excommunicatus tractari, ed il capitolo 92,
De honore vel gradu post abbatem caeteris
denegando. Verso la fine del capitolo 13 troviamo la seguente legislazione:
" I fratelli scomunicati, qualora si
dimostrino così superbi che ostinandosi nell’orgoglio del loro cuore, al terzo
giorno, all’ora nona, non abbiano ancora voluto dar riparazione all’abate,
verranno messi
in prigione e battuti a vergate fino al sangue (Letter. “Fino alla morte), e
se parrà bene all’abate siano espulsi dal monastero; ... È giusto dunque che
questi tali debbano essere presi a vergate ed espulsi,...”
Riguardo a ciò possiamo solo dire che i
romani loro contemporanei conoscevano questo tipo di battiture meglio di noi al giorno d’oggi, così
che San Benedetto e la sua epoca non rimasero scioccati come noi alla loro
menzione. Inoltre l'ad necem caedantur
virgis (siano battuti a vergate fino al sangue) è usato in parte in senso
figurato, perché l'abate può ancora espellere questi uomini dal monastero dopo
che la punizione è stata inflitta. Non si pensa assolutamente di picchiare a
morte.
Per quanto riguarda il secondo esempio, il
comando piuttosto irragionevole di cambiare costantemente l'ordine di rango
nella comunità, dobbiamo tenere presente il motivo alla base della legge. La RM
mira al progresso spirituale dei monaci. Il
magister vuole che siano umili e non
cerchino gli onori della carica, in modo che possano essere "più inclini a
competere tra loro in buone azioni ed umiltà (certatim
omnes in bonis actibus, vel in humilitate faciat propensare)" (Cfr. Cap. 92,
1045C). La legislazione non è un mero capriccio di un abate dittatoriale e
nemmeno è necessariamente contraria al carattere di San Benedetto. Lo spirito
che sta dietro ad essa sembra essere molto in linea con le parole del prologo di
San Benedetto: “Se qualcosa è in qualche modo rigorosamente stabilito per
l'emendamento dei vizi. ... "
È stato affermato che la RM è un commento
alla Regola di San Benedetto. Se è un commento, allora perché l'autore non segue
la normale procedura di un commentatore, come fa così bene nel commento al Padre
Nostro che segue immediatamente il suo Prologo? Se rendiamo la RM un commento
della Santa Regola, allora siamo costretti a concludere che l'autore della RM
possedeva una strana combinazione di buon senso comune e di profonda intuizione
spirituale, ma una totale mancanza di procedura logica ed una mancanza di gusto.
Il suo commento procede in modo molto confuso. Invece di seguire i capitoli di
San Benedetto in successione, salta da uno all'altro, ne divide alcuni e
distribuisce sezioni di altri a piacimento in tutta la sua opera. Egli aggiunge
idee irrilevanti e non commenta alcune delle sezioni più belle della Regola.
Come commento la RM non ha senso.
Inoltre, è psicologicamente malsano
considerare la RM come successiva a San Benedetto, poiché quella posizione ci
costringerà ad accettare una teoria secondo cui l'autore della RM, possedendo
alcuni tratti mentali molto peculiari, ha prodotto una caricatura della Regola
di S. Benedetto. Perez de Urbel, ad esempio, nel discutere la liturgia della RM
dice: "È vero che il Maestro non parla degli inni
Te Deum o Te Decet, ma non
si può vedere in questo dettaglio un segno di antichità, poiché noi sosteniamo
che è contrario agli inni di ogni tipo, che sono stati formalmente esclusi dalla
liturgia in una parte notevole dell'Occidente". Ne testimoniano anche le
dichiarazioni piuttosto severe di Dom Justin McCann. Dopo aver parlato della
gentilezza e della cortesia che San Benedetto si aspetta dai suoi monaci, Dom
McCann afferma che "tale riconoscimento dei diritti personali e delle
distinzioni personali è estraneo allo spirito e contrario ai principi"
dell'autore della RM. Nel confrontare la prescrizione del Maestro (RM cap. 2) e
quella di San Benedetto (cap. 7) “Nel
consigliarsi con i fratelli”, dice Dom McCann: “Il Maestro,
more suo, ha storpiato il testo di San
Benedetto di questo capitolo e abbiamo l'impressione che non gli interessasse
molto questa disposizione; ma che comunque c'è. "
Ancora una volta Dom McCann dice: "Perché
ci sembra che la spiegazione più semplice di queste numerose differenze omogenee
è che il Maestro abbia esaminato il testo di San Benedetto, per così dire, con
la sua matita blu editoriale ed abbia cancellato ogni passaggio che implicava
che i monaci dovessero avere un ordine fisso o dovessero ricevere un trattamento
differenziato per una ragione qualsiasi. "
Dom Cappuyns sorvola sulle incongruenze che
siamo costretti ad imporre al carattere di Cassiodoro, se vogliamo accettarlo
come l'autore della RM. Egli occulta l'intero assunto con l'affermazione: “Il
linguaggio, lo stile, le fonti simili, la dottrina ed i dettagli bizzarri di
ogni tipo che sono caratteristici di quest'ultima (RM), ci costringono ad
imputarne la paternità a Cassiodoro. "
Queste conclusioni seguono necessariamente
l'ipotesi che la RM sia stata scritta più tardi della Regola di San Benedetto.
Inoltre, se esaminiamo la RM, la sua unità di stile e di scopo viene facilmente
rilevata. Questa unità lega l'intera RM, dal capitolo 1 al capitolo 95, in un
tutto composito. I dettagli della vivida descrizione che si trovano nel primo
capitolo sono caratteristici di diversi altri capitoli, come ad esempio i
capitoli 25, 26, 27, 69, per citarne solo alcuni. Lo stesso andamento delle
intestazioni dei capitoli mostra un'unità di intenti nella Regola. Tutte le
intestazioni concernono direttamente le regolamentazioni spirituali e temporali
delle comunità di monaci sotto un abate.
Confrontando lo stile e gli artifici
retorici della RM con quelli della Regola di San Benedetto, viene messa in luce
la somiglianza stilistica. I punti di confronto includono: a)
clausulae; b)
responsio; c) frasi che assomigliano a versi; d) rima ed assonanza.
a)
Clausulae (= Conclusione di un periodo o di una frase)
Le percentuali riportate di seguito per le
clausulae della Regola di San
Benedetto sono state ricavate dagli elenchi di
clausulae quantitative e accentuali fatte da Dom Anselmo Lentini nel
suo studio sul ritmo in prosa di San Benedetto
[17].
Nelle presenti tabelle sono incluse solo
clausulae in posizione finale.
|
R.M.
Planus
32.2%
Velox
31.2%
Taddus
19.2%
Trispondaicus
4.8%
Medius
4.8%
Dispondeus dactylicus
0.96%
No cursus
6.7% |
Regola di San Benedetto
Planus.
30.7%
Velox
11.2%
Taddus
16.3%
Trispondaicus
13.2%
Medius
14.6%
Dispondeus dactylicus.
3.2%
No cursus
10.6% |
La percentuale dell'uso di parole di cinque
o più sillabe nella posizione finale è del 3,8% per la RM e del 12,4% per la
Regola di San Benedetto.
A giudicare da tutti i dati precedenti, si
deve concludere che le due Regole sono state scritte da due autori distinti o
che lo stesso autore abbia interrotto l'uso studiato delle
clausulae. Quest'ultima conclusione è abbastanza probabile poiché,
da giovane, San Benedetto si trovò di fronte al compito di scrivere una Regola
per i monaci che si erano posti sotto la sua guida. Mentre scriveva, si
conformava naturalmente agli standard di scrittura formale che aveva imparato a
scuola. Più tardi, quando tornò a rivedere il suo precedente lavoro, essendo ora
più vecchio, meno preoccupato dello stile e più concentrato sulla precisione e
immediatezza nella legislazione, trascurò in larga misura il ritmo della prosa.
Inoltre, le differenze osservate nell'uso delle
clausulae non mostrano un'incongruenza di stile, ma
piuttosto un'osservanza meno rigorosa di un tecnicismo della retorica. La
consistenza nell'uso del cursus nelle
due Regole è indicata dal fatto che la RM osserva una normale tipologia del
59,7% delle occorrenze del cursus planus
negli esempi riportati, e la Regola di San Benedetto osserva il
cursus planus nel 56,3% di tutti i suoi utilizzi del
planus.
b)
Responsio
Il ritmo della prosa non si esaurisce nel
susseguirsi di proposizioni considerate singolarmente. Nella Regola di San
Benedetto le cadenze delle frasi successive sono spesso armonizzate in modo che
la ripetizione regolare dello stesso o di un simile finale ritmico produca un
piacevole effetto sonoro. L'uso di questo espediente retorico si chiama
responsio.
I due esempi riportati di seguito indicano
il tipo di responsio che si trova
nella Regola di San Benedetto.
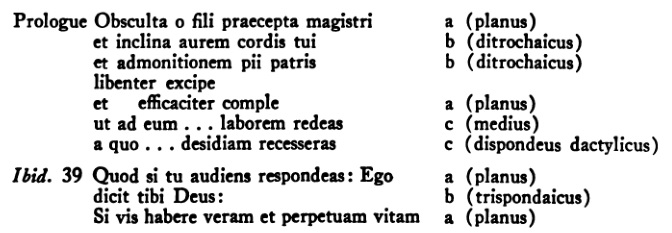
I seguenti esempi di
responsio presi dalla RM sembrano molto simili a quelli di San
Benedetto.
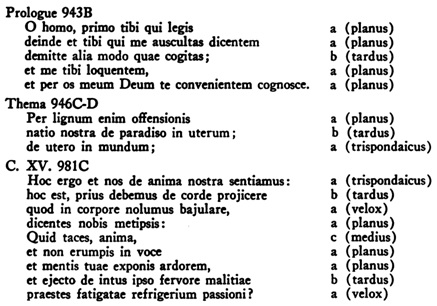
c)
Frasi che assomigliano al versetto
Nella regola di San Benedetto, oltre alla
responsio di
clausulae, troviamo spesso due frasi o clausole che producono
l'impressione di distici in versi. Così l'osservazione vale anche per la RM,
come indicano gli esempi sopra citati sotto
responsio ed i seguenti esempi.
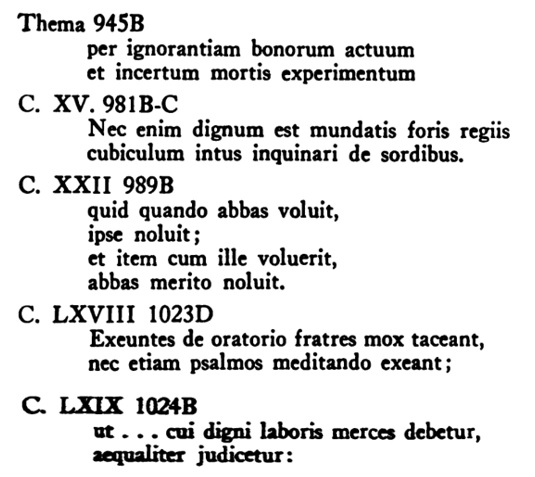
d)
Rima ed assonanza
"L'assonanza, e spesso la rima genuina, è
così frequente nella Regola di San Benedetto, che non possiamo ignorarla in
silenzio", dice Dom Lentini. Le stesse parole possono essere applicate alla RM.
Esempi tratti dalle due Regole, posti in colonne parallele, mostrano che questa
caratteristica è comune allo stile di entrambe.
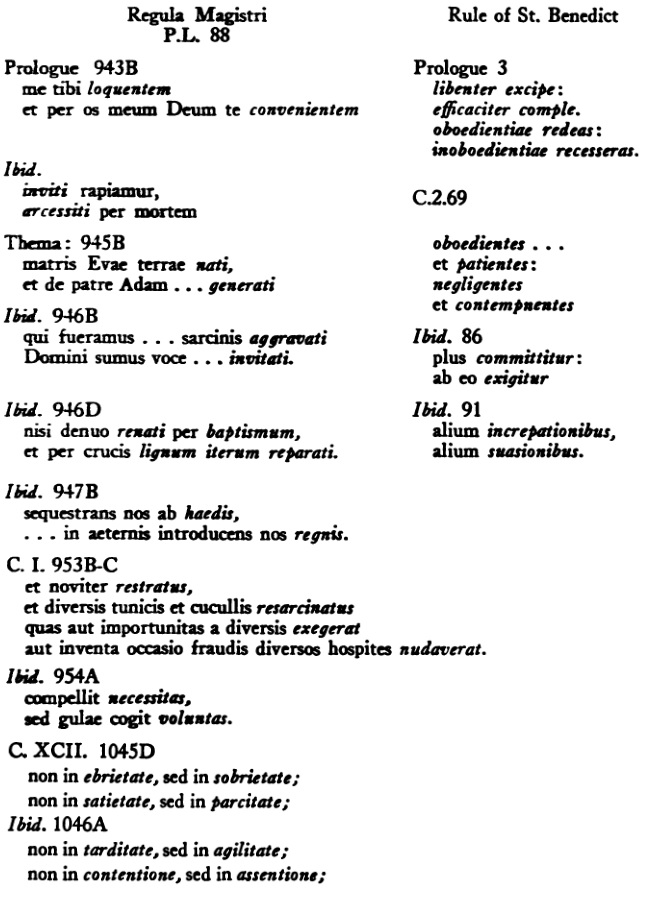
Esempi di
somiglianze retoriche e stilistiche nelle due Regole potrebbero essere
moltiplicati ancor più, ma quelli sopra riportati sono sufficienti a dimostrare
un'altra notevole somiglianza che esiste tra la RM e la Regola di San Benedetto.
In conclusione,
si deve riconoscere che le intricate interrelazioni psicologiche tra le due
Regole e l'intreccio dell'identità testuale non possono essere spiegate in modo
soddisfacente, a meno che non si ponga un autore per entrambe le Regole. Siamo
certi che San Benedetto ha scritto la Regola che abbiamo oggi. Se accettiamo la
RM come il suo lavoro giovanile, allora abbiamo una spiegazione naturale per la
sua paternità, la sua data ed il luogo di origine, e possiamo anche dare un
ragionevole conto delle differenze psicologiche che esistono tra la RM e
l'attuale Regola di S. Benedetto. Se una persona prima di San Benedetto ha
scritto la RM, allora San Benedetto resta privo di ogni pretesa di originalità.
Ma le parole di san Gregorio Magno e del
sensus communis di tutti i secoli passati si oppongono a ciò. Inoltre, il
personaggio di San Benedetto, come abbozzato da Papa San Gregorio, sembra
coincidere con quello del Magister. La
RM difficilmente avrebbe potuto essere scritta dopo il tempo di San Benedetto,
perché la sua interpretazione diventerebbe allora priva di senso come un film al
contrario. Questa teoria comporta anche implicazioni ingiustificabili sul
carattere dell'autore della RM. Infine, le grandi somiglianze di retorica e di
stile sono una forte evidenza che le due Regole sono opera di una sola persona.
Possiamo concludere che la RM può essere meglio spiegata considerandola come
l'opera precedente di San Benedetto.
[1]
In seguito abbreviata in RM. Il testo è stato pubblicato nel volume 88,
col. 943-1052 della Patrologia Latina di J. P. Migne – Parigi 1850
[2]
D. M. Cappuyns, “L’auteur de la Regula Magistri: Cassiodore,”
Recherches de théologie ancienne et médiévale, XV (1948), 209-268.
Oltre a Cappuyns, anche i seguenti autori sostengono la priorità della
Regola di San Benedetto: D. B. Capelle, “Cassien, le Maître et saint
Benoît, "Recherches de théologie ancienne et médiévale, XI
(1939), 110-118; Aux origines de la Règle de saint Benoît," ibid.,
pp. 375-388; “Un plaidoyer pour la Règle du Maître,” ibid., XII
(1940), 5-32; “Le Maître anterieur a saint Benoît?” Revue d’histoire
ecclésiastique, XLI, (1946), 66-75.—D. A. Lambert, “Autour de la
Règle du Maître,” Revue Mabillon, XXXII (1942), 21-79.—D. C.
Lambot, “Passage de la Regula Magistri dépendant d’un manuscrit
interpolé de la Règle
Bénédictine,” Revue Bénédictine, LI (1939), 139-143.—D.
J. McCann, “The Rule of the Master,” Downside Review, LVII
(1939), 3-22; “The Master’s Rule Again,” ibid., LVIII (1940),
150-159. D. J. Pérez de Urbel, “La Règle du Maître,” Revue d’histoire
ecclésiastique, XXXIV (1938), 707-739; “Le Maître et saint Benoît,”
ibid., 756-764.
Gli autori che seguono sostengono
invece
la priorità della R.M.: D. M. Alamo,
“La Règle de saint Benoît éclairée par sa source, la Règle du Maître,”
Revue d’histoire ecclésiastique, XXXIV (1938), 740-755; “Noveaux
éclaircisements sur le Maître et saint Benoît,” ibid., XXXVIII
(1942), 332-360.—F.
Cavallera, “La Regula Magistri et la Règle de saint Benoît. Le
problème littéraire” Revue d’ascétique et de mystique, XX (1939),
225-236; “La Regula Magistri sa doctrine spirituelie,” ibid.,
337-368; “Où en est la question de la Règle du Maître et de ses rapports
avec la Règle de saint Benoît?” ibid., XXIV (1948), 72-79.—D. A.
Genestout, “La Règle du Maître et la Règle de saint Benoît,” Revue
d’ascitique et de mystique, XXI (1940), 51-112; “Le plus ancien
témoin manuscrit de la Règle du Maître, le Parisinus latin 12634,”
Scriptorium, I (1946-47, 129-142; “Unité de composition de la Règle
de S. Benoît et de la Règle du Maître d’après leur manière d’introduire
les citations de l’Ecriture,” Studia Anselmiana XVIII-XIX (1947),
227-272.—M. F. Masai, “La Règle de saint Benoît et Regula Magistri,"
Latomus VI (1947), 207-229.
[3]
McCann, “The Rule of the Master,” op. cit., pag.4.
[4]
Dom Cuthbert Butler, Sancti Benedicti Regula Monasteriorum (Friburgi,
Briagoviae, 1935).
[5]
Gregorii Magni Dialogi, ed. U. Morrica (Roma, 1942), II,36.
[6]
Cappuyns, op. cit., p. 265.
[7]
Sono state esaminate le seguenti sezioni della RM: Prologo;
Tema fino a col. 949D;
Capitolo 1, da 951C fino alla fine; Capitolo 2, 957A-B, Capitolo 3, da
958C fino alla fine; Capitolo 4, Capitolo 5, Capitolo 6, Capitolo 7, da
960B a 962C; Capitoli dal 62 al 79 compreso. La
Clausulae seguite da un
periodo, un punto esclamativo od interrogativo sono state considerate
come aventi posizione finale. Sono state escluse le citazioni della
Scrittura.
[8]
La base per il confronto è il criterio usato da Cassiodoro così come
indicato da Sorella Mary Josephine Suelzer,
The Clausulae of Cassiodorus
(Washington, D.C., 1944), pag. 18-20. Le percentuali per Cassiodoro si
trovano alle pag. 40-41.
[9]
B.H. Skahill, The Syntax of the Variae of Cassiodorus (Washington, D.C.,
1934), p. 200.
[10]
Gli esempi sono stati estratti dalle seguenti sezioni delle opere di
Cassiodoro: Institutiones,
Praefatio 1; Libro I, Cap. 14, 3.4 (Mynors, opera citata);
Expositio in Psalterium, Salmo
1 (PL, vol. 70, 96-100); De Orthographia (PL, vol. 70, 1239-1243).
[11]
Dialogi,
II, 3: magistri adiutor coepit existere; ibid. 8: quia magistri corpus
necare non potuit.
[12]
L’argomento degli articoli di Capelle e di Cappuyns, menzionati nella
precedente nota 2, è che la RM si basa su di una primitiva Regola di san
Benedetto.
[13]
Il fatto che la RM legifera per comunità grandi e piccole (cap. 11) non
contrasta necessariamente col fatto che sia stata scritta a Subiaco,
dove S. Benedetto aveva stabilito dodici monasteri di pari dimensioni,
secondo S. Gregorio (Dial.,
II, 3). Questi monasteri non poterono rimanere di pari dimensioni molto
a lungo, perché continuarono a crescere e ad espandersi.
Inoltre, S. Benedetto era a conoscenza di altre comunità della zona. Egli conosceva
Vicovaro e lo spirito dei suoi monaci ancor prima che gli chiedessero di
diventare loro superiore.
Se questi monaci avrebbero potuto mettersi sotto la sua guida mentre era
ancora un eremita, non è certo irragionevole supporre che altre abbazie
dei dintorni avrebbero voluto adottare la sua Regola dopo che Benedetto
fondò i suoi dodici monasteri.
[14]
Questo testo è utilizzato come base per affermare che la RM non è stata
scritta in Italia. Si confronti Pérez de Urbel, “La règle du Maître,”
op. cit., Pag.734; McCann, “The Master’s Rule Again,” op. cit. pag. 153
n.1. Il testo latino della RM recita così:
dicunt se porro a finibus advenire
Italiae. Dom McCann lo traduce così: “e dichiarano di aver fatto
molta strada, dai confini dell’Italia” (Ibid., pag.154). Il testo latino
non implica necessariamente che gli oratori non fossero residenti sul
suolo italiano.
Aggiunta del
traduttore.
Nella nota relativa a questo argomento che si trova nel volume 2° della
Regola del Maestro a cura di Marcellina Bozzi OSB, Paideia Editrice
1995, si legge: “a finibus…
Italiae: espressione ambigua, potendosi intendere che hanno
attraversato tutta l’Italia, venendo dai suoi confini, oppure che
giungono da un paese lontano cioè l’Italia; con
fines = territorio, secondo un
uso più comune”.
[15]
Paul Delatte, “Commentario alla
Regola di S. Benedetto”, a cura del convento di S. Benedetto in
Bergamo, 1951, pag. 121.
[16]
L’ultimo paragrafo di questo capitolo, la descrizione delle gioie del
cielo, è tolto quasi letteralmente dalla leggenda di san Sebastiano (AA.
SS. II, Gen. 20), 631.
[17]
Dom Anselmo Lentini, Il ritmo
prosaico nella Regola di S. Benedetto (Montecassino, 1942). Gli
elenchi di clausulae, che includono solo quelle in posizione finale, sono
contenuti nelle pagine 35-43. Lo
spondaicus dactylicus è trattato come
medius ed il
dactylicus spondaicus come
planus. Dom Lentini elenca le
clausulae nelle quali non si
trovano ritmi particolari alla pagina 56.
Ritorno alla pagina iniziale: "Regole monastiche e conventuali"
| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |
| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |
4 ottobre 2020
a cura
di
Alberto "da Cormano" ![]() alberto@ora-et-labora.net
alberto@ora-et-labora.net