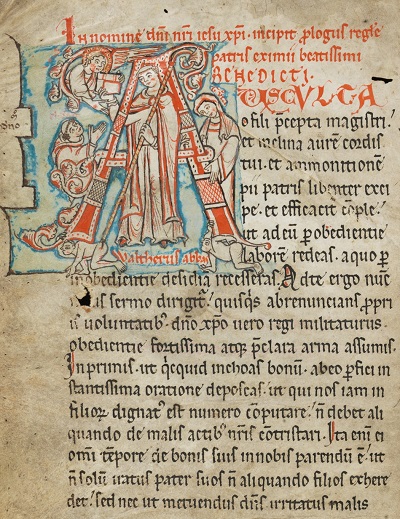|
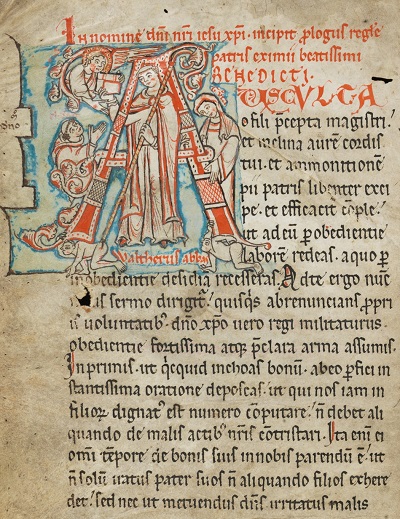
P. Benedictus Gottwald, Catalogus codicum
manu scriptorum qui asservantur in Bibliotheca Monasterii O.S.B.
Engelbergensis in Helvetia, Freiburg im Breisgau 1891, p. 100.
|
Il
monachesimo italiano dal
Maestro
a san Benedetto;
la regola
benedettina
di Salvatore Pricoco
estratto da "Storia del cristianesimo:
L’antichità"
a cura di
Giovanni Filoramo e Daniele Menozzi - Editori
Laterza
|
Dopo la grande stagione del
monachesimo provenzale, e
certamente anche per suo influsso, nel VI secolo hanno luogo in Italia gli
episodi di più forte e creativo rinnovamento monastico. Nelle regioni
centromeridionali, sotto l’influenza ravvicinata della chiesa di Roma, vengono
redatte le due regole più importanti e originali, quella del Maestro e quella di
san Benedetto, e si sviluppa in alcuni monasteri - come quelli di Fulgenzio in
Sardegna e di Eugippio in Campania - un fecondo dibattito dottrinale sulle
idealità monastiche, sull’arianesimo, sul pensiero di Agostino.
Secondo il racconto tradizionale Benedetto
nacque a Norcia nel 480 da una famiglia cospicua. Mandato a Roma per completare
gli studi, ne ebbe presto disgusto e abbandonò la città per una vita più
ritirata, e dopo avere vissuto per tre anni in assoluta solitudine in una
spelonca presso Subiaco, allorché si raccolse attorno a lui un gruppo di
discepoli attratti dalla sua virtù e dai suoi prodigi, li organizzò in dodici
piccole comunità. Più tardi, lasciò i monasteri sublacensi per dare vita in una
località ancora dedita a culti pagani, presso Frosinone, a un’unica, più grande
comunità monastica: l’abbazia di Montecassino. Per essa il Santo scrisse la sua
Regola
gloriosa e in essa, dopo quasi vent’anni impegnati nelle opere di costruzione
del convento, nell’evangelizzazione delle popolazioni circostanti, in
un’esistenza fitta di atti miracolosi e di pratiche virtuose, si spense, tre
giorni dopo la sorella amatissima, Scolastica. In realtà questo racconto non ha
alcun fondamento documentario. Esso è ricavato dai
Dialogi
di Gregorio Magno, l’opera che l’insigne papa scrisse tra il 593 e il 594 sui
santi italiani e i loro miracoli, riservando in essa a Benedetto l’intero libro
secondo. Ma i
Dialogi
sono l’opera forse più discussa di tutta la letteratura altomedievale, oggetto
di dibattito critico non meno che di scontri ideologici da quando, a partire
dagli storici protestanti del XVI secolo, ci si è chiesti come fosse possibile
collocare nella produzione letteraria di Gregorio un’opera di scoperta
affabulazione popolaresca come i
Dialogi
e accordare il loro basso livello letterario, l’ingenuità dei racconti, il
miracolismo esagerato con l’alta dottrina e la spiritualità del grande papa.
Non sono stati pochi, perciò, gli studiosi che si sono pronunciati per
l’atetesi dell’opera. Più di recente alcuni, di conseguenza, hanno finito col
negare qualsiasi valenza documentaria alle pagine su Benedetto (rappresentato
come «uomo di Dio», asceta di insuperabile virtù e, più ancora, operatore
infaticabile di miracoli di ogni tipo, guaritore, suscitatore di morti,
veggente, mai come legislatore sapiente e creatore geniale di nuove forme
monastiche), hanno rifiutato l’identificazione del
Benedictus
al quale la maggior parte dei manoscritti attribuisce la
Regola
con l’eroe del libro gregoriano, hanno addirittura posto in dubbio che sia
realmente esistito il personaggio del quale una storia millenaria ha fatto il
fondatore del cenobitismo europeo.
Oggi non è più questione della realtà storica di
Benedetto e le posizioni di massimalismo e oltranzismo critico hanno ceduto a
convincimenti più equilibrati. Nel racconto dei
Dialogi
si riconosce, al di là del soverchiante impianto affabulatorio, un sostrato
storico verificabile; l’attività di Benedetto nell’area circostante a Roma e
il suo ruolo di fondatore di monasteri e di animatore di esperienze monastiche
nuove non sono più in discussione. E se non sono più accettabili le date entro
le quali la tradizione ha inscritto la biografia di Benedetto, la progredita
conoscenza del quadro storico
complessivo, una diversa e più puntuale ricognizione dei riflessi che la
società dell’epoca ha lasciato nel testo benedettino, un più attento confronto
con la legislazione imperiale, con le altre regole monastiche, con i testi
letterari e biblici in circolazione consentono di fissare riferimenti temporali
non perentori, ma di grande verosimiglianza e buona approssimazione. Il 490-500
per la nascita, il 530 circa per l’arrivo a Montecassino, il 560 circa per la
morte sono le date sulle quali si è oggi realizzato il consenso quasi unanime
degli studiosi. Entro di esse, dalla maturità alla morte del Santo, non è
possibile assegnare una data precisa alla redazione della
Regola.
Di qualche capitolo è rintracciabile il
terminus
post quem o quello
ante quem
in virtù delle fonti che vi sono utilizzate, ma l’arco di tempo che se ne
ricava è assai ampio e può estendersi anche a un trentennio: verosimilmente, il
trentennio del soggiorno di Benedetto a Cassino, tra il 530 e il 560.
Sostanzialmente chiusa appare
oggi anche l’altra questione (peraltro strettamente connessa alla prima),
riguardante l’originalità della regola benedettina. La
Regola di
Benedetto coincide in modo manifesto, nei contenuti e nella
struttura, con un altro testo, la cosiddetta
Regola del
Maestro. Nella parte iniziale, dal prologo al capitolo settimo, la
coincidenza è letterale, parola per parola; nel resto vi sono forti e continue
analogie di contenuto; solo gli ultimi sei capitoli, dal 68 al 73, non trovano
riscontro nella
Regula
Magistri. Questa è la più lunga delle antiche regole latine (più
che tripla rispetto alla
Regola di
Benedetto, doppia rispetto a quella di Basilio tradotta da Rufino)
e la più ricca sia di precetti riguardanti la prassi monastica che di
considerazioni teoriche sulla spiritualità ascetica. Per molto tempo le
macroscopiche analogie tra le due regole non hanno inquietato i loro lettori e
la
Regula
Magistri, rimasta a lungo pressoché ignorata, fu ritenuta
nient’altro che una tardiva e prolissa amplificazione della regola benedettina.
Ma alla fine degli anni Trenta alcuni studiosi rovesciarono il rapporto
tradizionalmente accettato e sostennero che la
Regula
Magistri non è un’imitazione, ma la fonte primaria della
Regula
Benedicti. Ne derivò, specialmente dopo la fine del secondo
conflitto mondiale, una controversia accesissima, poiché riconoscere il testo
benedettino tributario sino al calco letterale di una regola precedente
significava incrinare consolidate certezze storiografiche e chiedersi fino a
che punto fosse lecito continuare a vedere in Benedetto il grande, unico padre
del monachesimo europeo.
Oggi si riconosce quasi da tutti l’anteriorità
del Maestro rispetto a Benedetto. Ricche e approfondite analisi sono venute
mostrando l’unità compositiva e stilistica della
Regula
Magistri e tutta una serie di peculiarità (nella lingua, nella
completezza e concretezza normativa, nell’utilizzazione delle fonti, nella
liturgia) che attestano in essa un testo elaborato organicamente e con
originalità. Meglio inserita nel quadro della prima legislazione monastica, la
Regula
Magistri appare anche meno misteriosa; sono via via cadute molte
delle proposte, talune criticamente inconsistenti e persino bislacche,
sull’autore, sul luogo e la data di redazione. Essa viene oggi datata ai primi
decenni del VI secolo, non prima del 500 circa, poiché non sono anteriori a
questa data taluni scritti, come la
Vita s.
Silvestri, dei quali si colgono in essa tracce indubitabili, né
dopo Eugippio, che intorno al 530 ne trasse numerosi escerti per la sua
regola-centone. Il luogo della redazione, dopo le tante proposte avanzate -
dalla Dacia e dall’ambiente di Niceta di Remesiana al Norico di san Severino,
dalla Calabria di Cassiodoro alla Spagna, dalla Gallia del monastero del Giura
o dell’isoletta di Lérins all’Italia settentrionale e Bobbio - viene oggi
collocato nell’Italia centrale, in una zona d’influenza romana.
Dall’altro canto sono stati rintracciati nella
Regula
Benedirti sia significativi elementi di seriorità (nella liturgia,
nella lingua ecc.), sia i procedimenti con i quali il legislatore di Cassino ha
utilizzato la sua fonte. Essa non fu scritta di getto, da un teorico della
vita monastica che vi abbia atteso a tavolino, nel chiuso del suo studio, ma, al
contrario, fu composta, per così dire, sul campo, cioè nella concreta
sperimentazione dell’esperienza vissuta e continua, da persona che si sia
scontrata con le difficoltà e le esigenze della realtà quotidiana e ne sia
stata con frequenza indotta a rivedere, riconsiderare, tornare indietro,
modificare punti di vista e soluzioni normative. La personalità del legislatore
è quella di uno spirito eminentemente pragmatico e perciò alieno dalle
dissertazioni teoriche magniloquenti e anche bizzarre del suo modello, ma
giammai dimentico dei fini unicamente spirituali della militanza monastica e
perciò più attento al progresso spirituale dei fratelli che alle occupazioni
concrete e agli adempimenti delle opere giornaliere, più compreso dell’alto
compito pastorale dell’’abate, responsabile di fronte a Dio (è una notazione
ricorrente nella regola) delle loro anime, che degli aspetti pratici della
direzione, interessato a comporre i fondamenti spirituali della prassi
cenobitica in una prospettiva rinnovata. Senza dimenticare la necessità del
rapporto verticale, tra l’abate e il monaco, ora l’accento viene posto sui
rapporti orizzontali, quelli che si stabiliscono tra i fratelli con
l’applicazione costante della carità, la principale delle virtù predicate dal
precetto evangelico. Si fa sentire più nettamente, tra tutte le voci della
tradizione, l’influenza di Agostino e del suo concetto del cenobio, nel quale i
monaci interiorizzano la loro personalità a immagine di Cristo donandosi ai
fratelli in un continuo rapporto di mutua misericordia e di amore.
Oltre
che
con Agostino, Benedetto
ha
debiti continui con tutta la tradizione, e non
soltanto in materia di dottrina e di istituzioni, ma nella struttura, nell’uso
di immagini e metafore, nel vocabolario, perfino in talune movenze dello stile.
Questo fitto ordito indica in lui, di contro al mito storicamente inconsistente
del legislatore genialmente rivoluzionario, creatore
ex nihilo
di un nuovo ordine religioso, l’accorto erede della tradizione, l’abate sagace
che ha fornito le sue comunità
del frutto prezioso della sapienza monastica ricevuta dai suoi predecessori.
Tutti i padri del
monachesimo occidentale furono
consapevoli di essere eredi del passato, di un patrimonio comune da conservare
e trasmettere. Il testo benedettino fu più apprezzato di altri non per la sua
originalità, ma per la ragione opposta, cioè
perché sembrò, più
e meglio di altri, una sintesi
della precedente esperienza monastica: è questo il fondamento critico della
comparazione con le altre regole che
ne fece in età carolingia Benedetto di Aniane e del primato assegnatogli
su tutte. Felicità della sintesi, equilibrata moderazione e vigile senso della
misura (omnia mensurate fiant, è detto nel cap. 48), capacità di
discernimento, realismo mai disgiunto dalla considerazione dei fini superiori,
giusto rapporto tra prassi e teoria, chiarezza del progetto pedagogico: queste,
e altre ancora, sono le qualità che sogliono essere riconosciute a Benedetto.
Per esse la sua regola, a differenza di quasi tutte le altre, non è diventata
documento di mero interesse storico-archeologico, ma è stata per secoli, e
continua a essere, strumento di attiva e concreta vita monastica.
D’altra parte la diffusione della regola
benedettina fu tutt’altro che rapida. Per più di due secoli, dopo la morte di
Benedetto, essa non fu né largamente nota né diffusamente applicata. Dopo la
distruzione di Montecassino a opera dei Longobardi (577 ca.) e l’esodo dei
monaci cassinesi non conosciamo fondazioni benedettine nell’Italia suburbicaria
né altrove; non furono di osservanza benedettina i monasteri romani e quello
stesso di Sant’Andrea, nel quale condusse vita monastica Gregorio Magno. Fatta
eccezione per le allusioni di Gregorio nei
Dialogi,
la prima menzione della
Regola
si legge in una lettera che Venerando, fondatore e abate del convento di
Altaripa nell'Aquitania, inviò intorno al 620-630 al vescovo di Albi, Costanzo.
Per tutto il VII secolo il codice benedettino è menzionato assieme ad altre
regole, come un testo al quale ispirarsi per trarne - secondo la consuetudine
della
regula
mixta - suggestioni e precetti, ma senza farne il regolamento
imperioso e univoco della vita conventuale; echi e accenni negli scritti
agiografici o in qualche canone conciliare non bastano a provarne l’uso
esclusivo nei monasteri franchi. Fu solo nel secolo Vili che la
Regula
Benedirti cominciò ad avere diffusione europea, per finire poi -
per volontà della monarchia carolingia - con l’imporsi sulle altre. Da allora,
per secoli, l’Europa monastica sarà largamente benedettina.
Il nuovo introdotto da Benedetto nella prassi
conventuale fu tutt’altro che rivoluzionario. In generale, c’è nella
Regola di
Benedetto un’attenzione più viva per i rapporti all’interno della
comunità, che trae origine non solo dalla lezione agostiniana e dallo spirito
pragmatico del legislatore, ma anche da una condizione di più allentata
pressione gerarchica e di cresciute resistenze all’interno della comunità nei
confronti dell’autorità dell’abate. Molta attenzione è dedicata alle norme
sull’ingresso nel cenobio (cap. 58), poiché, a causa dei mutamenti sociali
determinati dal lungo e rovinoso conflitto goto-bizantino e delle condizioni di
miseria e di insicurezza, il monastero appariva spesso l’unica via alla
sopravvivenza. La volontà della comunità di difendere l’accesso al chiostro ed
evitare che il monastero diventi il rifugio di emarginati, fuggiaschi,
miserabili è evidente in tutte le regole monastiche antiche e tutte hanno
cercato di saggiare nei postulanti la sincerità della vocazione e la
consapevolezza dei propositi. Complessivamente Benedetto non rende più
difficili i riti e le condizioni per l’ammissione; le prove dì tolleranza e
umiltà che Paco- mio richiedeva al postulante in attesa alla porta del monastero
erano certamente più dure e spettacolari; più aspre erano quelle previste
dalle
Regole dei
Padri. Ma ora vengono moltiplicate le riserve per assicurarsi se
il postulante «cerca veramente Dio»,
revera Deum
quaerit, vengono infittite le messe in guardia sulla radicalità
dei mutamenti di vita che l’ingresso nel monastero comporta e sulla loro
irreversibilità. Benedetto è ancora più cauto e difensivo del Maestro; egli
abbrevia e sintetizza, come è suo costume, la sua fonte e ne attenua il tono
inquisitorio e ostile, ma le limitazioni opposte al candidato sono in lui, sin
dal secco ammonimento iniziale, più aspre e perentorie; la rapidità formulare
con la quale lo avverte di come sia dura la via del Signore e inammissibile il
ritorno allo stato laicale è indubbiamente più scoraggiante delle lunghe e
minacciose allocuzioni del Maestro.
Trova frequente espressione, anche, la
consapevolezza della debolezza dei fratelli e della decadenza dei loro costumi
rispetto agli antichi modelli. Da qui una costante tendenza a mitigare gli
obblighi e le fatiche della giornata monastica e a rivedere il regime penale. Il
complesso delle pene previste per reprimere e correggere le infrazioni, se
continua ad ammettere, com’era nello spirito dei tempi, lo scopo punitivo della
norma e prevede senza troppe esitazioni la
vindicta
corporalis, cioè l’uso del bastone e della sferza, è
complessivamente meno puntiglioso e fiscale, più misericordioso e più spesso
ispirato dalla volontà di comprendere l’errore e di recuperare gli erranti. Per
quanto riguarda la prassi quotidiana, sia in rapporto al Maestro che alle regole
più antiche, sono diventati più brevi i tempi della preghiera comune e della
liturgia, è allungato il periodo estivo, che accorcia l'ufficio notturno, è
meno severo il regime dei digiuni. I capitoli sul regime liturgico hanno
un’accuratezza nuova. Il servizio divino ha un ruolo prioritario rispetto agli
altri adempimenti della vita conventuale e costituisce lo strumento primario per
la formazione spirituale del monaco. Il suo andamento più svelto in confronto al
Maestro e all’ufficio romano classico è da mettere in relazione con la diversa
strutturazione imposta alla giornata monastica dalle nuove esigenze lavorative.
Il
capitolo che è sembrato più nuovo di ogni altro è il cap. 48, sul lavoro,
quello, per intenderci, dal quale deriva il precetto con cui si suole indicare
l’essenza del monachesimo benedettino:
ora et
labora. Esso prevede il lavoro nei campi, ancora escluso dal
Maestro, e fissa le ore lavorative e quelle destinate alla preghiera tenendo
presenti le esigenze del lavoro nelle diverse stagioni. Ma vi si fa largo spazio
anche alla lettura. Da Pasqua a ottobre i monaci sono tenuti a lavorare dalla
prima ora alla quarta, dalla quarta alla sesta attendano alla lettura,
lectioni
vacent. Negli altri sei mesi, da ottobre a Pasqua, l’ordine è
invertito: si attende alla lettura al mattino, fino all’ora seconda, poi si va
al lavoro. Nei giorni di quaresima la lettura è protratta sino all’ora terza;
inoltre, all’inizio della quaresima, tutti riceveranno un libro dalla biblioteca
e lo leggeranno per intero, ordinatamente dal principio alla fine.
In realtà, dunque, la celebre
formula con la quale si suole compendiare la giornata del monaco benedettino,
deve essere completata così:
ora, labora et lege,
«prega, lavora e leggi». Ed è per
merito di questa triplice prescrizione che si è svolta nei secoli quell’opera
preziosa di conservazione e trasmissione della cultura di cui siamo debitori
agli antichi monasteri e, in particolare, a quelli benedettini.
Accanto alle grandi figure del Maestro e di
Benedetto, ci sono anche altri personaggi da recuperare nel quadro del
monachesimo del VI secolo. Da un monastero della Sardegna vandala, dove visse in
esilio fino alla morte di Trasamundo (nel 523), il più alacre teologo di questi
decenni fu l’africano Fulgenzio, che diffuse i suoi scritti contro l'arianesimo
ed ebbe tra i suoi interlocutori vergini consacrate, come la nobile Proba, o
monaci illustri, come Eugippio, abate del Lucullanum presso Napoli. E una rete
di relazioni, questa, di non piccolo significato. Proba era un’aristocratica,
forse la figlia di Quinto Aurelio Simmaco e perciò imparentata con Cassiodoro e
Boezio; a lei Dionigi il Piccolo dedicò la traduzione della
Vita
di Pacomio; Fulgenzio le inviò due lunghe lettere sulla verginità, l’umiltà e
la preghiera e ne esaltò le eccezionali virtù cristiane nella lettera alla
sorella di lei, la vedova Galla. Era una donna colta, che possedeva una
biblioteca notevole, nella quale erano accolti scritti di Agostino, gli stessi
(almeno in parte) dai quali Eugippio trascelse un florilegio, che le dedicò. A
comporre questa silloge di
Excerpta
Augustini l’abate del Lucullano probabilmente si servì della
biblioteca di Proba, mentre alla biblioteca del Lucullano fece ricorso
Fulgenzio. Con Eugippio fu in relazione anche Ferrando, il biografo di
Fulgenzio, il quale indirizzò all’abate campano due lettere, una delle quali è
un breve trattato dogmatico sulle differenze tra arianesimo e fede cattolica,
stilato per rispondere alle domande che un nobile goto aveva rivolto a Eugippio.
Risulta evidente, dunque, la presenza di questo monastero campano nel dibattito
culturale di questi anni e indubbia l’opera di promozione e veicolazione da esso
svolta almeno in un settore: quello della conoscenza dell’opera e del pensiero
di Agostino. E si tratta di un tema di grande importanza per la comprensione
del monachesimo italiano di questi anni, se si tiene presente, oltre al sicuro
legame che l’agostinismo costituisce tra questi tre personaggi e i diversi
ambienti che li esprimono, la crescente rilevanza che gli esegeti moderni sono
venuti attribuendo alla presenza di Agostino nella
Regola di
Benedetto. Eugippio fu autore, oltre che della raccolta di escerti
di Agostino, di una
Vita di s.
Severino del Norico e di una
Regula
mixta, redatta in anni prossimi alla morte (intorno al 530) e che
accoglie due testi della
Regola di
Agostino e 45 estratti dalle regole di Basilio (nella traduzione
di Rufino), del Maestro, di Paco- mio (nella traduzione di Girolamo), da
Cassiano, dalla
Regola dei
quattro Padri. Non si tratta di semplici estratti di lettura, ma
di un florilegio compilato con un ordine logico e con una destinazione pratica,
cioè di una regola-centone, redatta per essere applicata in un monastero. Tra il
Maestro e Benedetto ecco dunque un altro legislatore operare in questa parte
dell’Italia. La sua regola-centone ha le dimensioni cospicue delle due grandi
regole italiane ed è sulla loro linea nella selezione delle fonti. Anche
Eugippio accoglie le voci delle massime tradizioni monastiche, l’Africa di
Agostino, l’Egitto di Pacomio, l’Oriente di Basilio, la Gallia di Cassiano e,
probabilmente, della
Regola dei
quattro Padri; addirittura egli sembra precorrere Benedetto nel
privilegio accordato ad Agostino e al Maestro e dunque alla cooperazione di due
concezioni della vita monastica, quella più severa e più autoritaria della
tradizione egiziana, e quella più mite, caritatevole e unanimistica di
Agostino.
In conclusione, se nel V secolo era stata la
Provenza, con le comunità di Lérins e di Marsiglia, con il rifiuto delle tesi
pelagiane ma anche dell'agostinismo più intransigente, con l’elaborazione delle
prime regole occidentali, a diventare il più fervido e creativo centro
monastico dell’Occidente, nel VI secolo è l’Italia, e più precisamente l’Italia
centro-meridionale, a diventare la patria delle iniziative monastiche più
importanti e durature. Nel meridione italiano, in Calabria, a Squillace, dopo
la metà del secolo Cassiodoro fonda un monastero, il
Vivarium,
che non ebbe vita lunga e si estinse quasi sicuramente con il suo fondatore, ma
svolse un grande ruolo nella cultura del tempo. Vi fu costituita una ricca
biblioteca e per i monaci del
Vivarium
Cassiodoro fece tradurre numerose opere greche. Egli stesso compose per loro
quelle
Institutiones che restarono per secoli uno degli scritti fondanti
della cultura medievale.
| Ora, lege et labora |
San Benedetto |
Santa Regola | Attualità di San Benedetto |
| Storia
del Monachesimo | A Diogneto |
Imitazione di Cristo | Sacra
Bibbia |
27 luglio
2015
a cura
di
Alberto "da Cormano"  alberto@ora-et-labora.net
alberto@ora-et-labora.net