Estratto da “Il monachesimo“ - Editori Laterza

Paolo Uccello, Episodi di vite di eremiti (Tebaide)
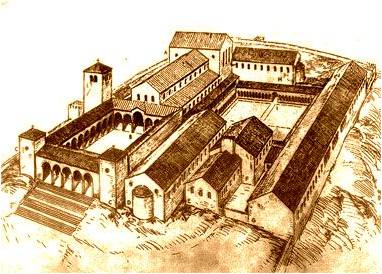
Monastero di Montecassino in un'antica stampa
|
di Salvatore Pricoco Estratto da “Il monachesimo“ - Editori Laterza |
|
 Paolo Uccello, Episodi di vite di eremiti (Tebaide) |
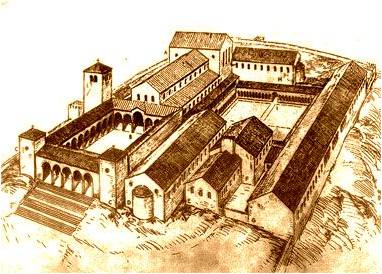 Monastero di Montecassino in un'antica stampa |
1. Le specie monastiche
Eremitismo e cenobitismo sono, come si è già avuto modo
di dire, le due forme principali della vita monastica. Forma originaria, e
caratteristica primaria del
monachesimo
universale, da quello indiano, bramanico o buddista a quello cristiano, suole
essere considerata la condizione dell’asceta che vuole vivere 'solo’, celibe e
libero da ogni coinvolgimento nella società, fisicamente distaccato da ciò a cui
rinuncia. A essa si suole dare il nome di anacoretismo (dal termine greco
anachòresis, che
propriamente è il trasferirsi da luoghi abitati nella solitudine della
chòra> il territorio
extra-urbano), o di eremitismo (dai vocaboli greci
eremìtes e
erèmos, entrati
nell’uso monastico solo attraverso l’uso
latino). Il cenobitismo (dal greco
koinòs bìos, «vita comune») è il genere di vita
religiosa di coloro che vivono insieme, raccolti in un medesimo luogo e
praticando un analogo regime di vita. L’ascetismo solitario può atteggiarsi in
maniera diversa: può essere stanziale o itinerante, può tradursi in solitudine
completa, quella dell’eremita che rifugge da ogni compagnia, o parziale, quella
dell’asceta al quale si affianca un giovane discepolo o un minuscolo
gruppo di seguaci. Il distacco può anche volere essere
il più radicale possibile e tradursi in
xenitèia, cioè nella scelta di un paese nel quale
l’asceta viva da straniero.
La nozione di unità e solitudine originariamente
presente nel termine «monaco» (dal greco
mònos, «solo», ma anche
«uno»; lat.
solus e
unus) ha dato lo spunto per un’interpretazione delle
origini del
monachesimo cristiano e della sua
prima fenomenologia. Il monaco è colui che impronta la sua vita all’unità,
consacrandola interamente al servizio di Dio. E colui che non ha l’anima
«doppia», ma ha come vuole la Bibbia un unico cuore, poiché non si impegna in
più attività. E colui che evita ogni molteplicità e dispersione, poiché tende
secondo una dottrina di origine ellenica, platonica, neoplatonica e largamente
sviluppata nella gnosi a unirsi all’Uno. Dalla ricerca dell’unità deriva il
primo e ineludibile requisito della condizione monastica, cioè il celibato, che,
affrancando da obblighi verso la famiglia, assicura l’amerimnìa, cioè
l’assenza di cure e preoccupazioni quotidiane. Dallo stato celibatario e
dall’amerimnìa che ne è il frutto discendono gli altri
fondamentali caratteri,
l’anachòresis e
l’apotaghè o
apòtaxis, la «rinunzia», cioè la pratica di quelle
forme di vita ascetica che favoriscono la concentrazione e proteggono dalla
dispersione delle forze mentali e spirituali.
I primi teorici
della vita monastica in particolare Basilio, il grande vescovo di Cesarea
autore, accanto alle opere teologiche, anche di fondamentali scritti
monastici, ed Evagrio Pontico, i cui trattati
avrebbero avuto grande influenza prima che egli venisse sconfessato per i suoi
debiti verso il pensiero di Origene indicarono le radici di questa dottrina
nella Sacra Scrittura, nel Vecchio come nel Nuovo Testamento. Con radicale
forzatura Basilio interpreta in senso monastico l’avvertimento rivolto in
Geremia (16,1-4) al
profeta a non prendere moglie né generare figli, perché essi periranno di morte
straziante e non saranno né compianti né sepolti. San Paolo nella
Prima lettera ai Corinzi
(7, 32-33), pur concedendo che ricorrano al matrimonio coloro che non riescano a
vivere in continenza, esalta il celibato, che mantiene
amerìmnoi,
sine sollicitudine,
«liberi da preoccupazioni» per le cose del mondo e solleciti solo delle cose del
Signore. I discepoli di Paolo, coloro che mettendone in pratica gli insegnamenti
seppero vivere in castità, solleciti solo delle cose del Signore, avrebbero così
messo in pratica un ideale ascetico e monastico, compiutamente e ripetutamente
delineato nella Bibbia e congenito dunque alla «essenza del cristianesimo».
Secondo alcuni antichi scrittori cristiani la forma
originaria dell’esperienza monastica è quella cenobitica e nasce con il
cristianesimo stesso. Essi si rifanno al racconto degli
Atti degli Apostoli
(4, 32), secondo il quale i primi cristiani raccoltisi a Gerusalemme, dopo la
morte di Gesù, misero in comune i loro beni e vissero insieme sotto la guida di
san Pietro, realizzando così la prima e perfetta forma di vita monastica.
Nell’Occidente questa dottrina fu sostenuta da san Gerolamo e da sant’Agostino,
ripetutamente e più riccamente da Cassiano. Questi, muovendo da altri passi
degli
Atti (15,1 sgg. :
sulle controversie nate a Gerusalemme e ad Antiochia riguardo alla circoncisione
e sull’allargamento della Chiesa ai Gentili), volle spiegare l’origine delle
varie forme di
monachesimo dei suoi tempi, ben lontane
dall’originaria perfezione apostolica, e sostenne che, quando la fede aveva
preso a declinare e i costumi a decadere, i cristiani più retti e devoti si
erano sottratti al contagio della massa, appartandosi in luoghi solitari,
lontano dalle città, e dando così vita, a imitazione dell’antica comunità
gerosolimitana, al monachesimo cenobita. Da
questo poi, assai più tardi, con l’abate Paolo e con Antonio, sarebbero derivate
una seconda specie di santi, quella degli anacoreti, come fiori e frutti da una
radice fecondissima, ma anche, degenerando, una terza specie di monaci, quella
dei sarabaiti, infedele e malvagia, che volge al male la professione monastica e
rinverdisce la mala pianta di Anania e Safira, recisa al tempo degli Apostoli
dalla severità di Pietro.
L’interpretazione cassianea dell’antica storia
monastica come un susseguirsi di fasi degenerative rispetto al modello
gerosolimitano e di reazioni volte a recuperare quel modello ebbe immensa
fortuna nella
tradizione medievale, costantemente
segnata dalla nostalgia delle origini, e la sua distinzione di tre tipi di
monaci, che già Gerolamo aveva delineato nella celebre lettera 22, a Eustochio,
fu accolta dal Maestro e da Benedetto, nel capitolo iniziale delle loro regole.
I tipi di monaci diventano quattro, due legittimi, anacoreti e cenobiti, due
condannabili e detestabili, girovaghi e sarabaiti. Di fatto i due legislatori
predicano senza riserve il primato dei cenobiti, il «fortissimo genere di quelli
che vivono nella comunità», che si sostengono e si controllano gli uni con gli
altri.
Il genere degli
anacoreti, «che vivono in solitudine nei deserti», è un genere di vita
altissimo, il culmine della ascesi cristiana, ma quasi inattingibile per le
difficoltà che presenta e i rischi a cui espone. Gli altri due generi sono fatti
di monaci indegni, impostori, insofferenti di qualunque disciplina, sempre in
giro a lucrare favori e scroccare elemosine. E lunga e irridente la polemica del
Maestro nei confronti di
gyrovagi e
sarabaitae, cioè di monaci
peregrini; è rapida
ma non meno perentoria la condanna di Benedetto.
Attraverso una complessa evoluzione istituzionale e
ideologica, che da Pacomio conduce a Benedetto, si precisano i modelli della
vita monastica e il loro fondamento normativo: la condanna di ogni forma di
monachesimo
non regolare, l’accettazione teorica del modello eremitico ma la sua reale
rimozione, il primato della vita cenobitica, garantita dalla
stabilitas, cioè
dalla permanenza a vita nel medesimo monastero, e dalla irrevocabilità del voto
monastico. Ma prima che si arrivi a un’osservanza generalizzata e ispirata ad
analoghe norme di condotta le situazioni permangono per secoli estremamente
frazionate e diverse. E sempre, accanto all’istituzione cenobitica o in
opposizione a essa, resteranno forme di ascetismo solitario, spontaneo,
carismatico, a volte riconosciuto e accettato come forma ‘altra’, più spesso
rifiutato e combattuto come eslege, destabilizzante o, addirittura, eretico.
2. L’eremitismo
L’istanza eremitica è una componente perenne del
monachesimo,
in tutte le religioni. Dialetticamente opposta al bisogno della
koinonìa,
della vita trascorsa in una struttura comunitaria dalla quale trarre norme e
sostegno per il perfezionamento spirituale, nasce dal bisogno di sentirsi liberi
e ‘soli’ per realizzare quel perfezionamento. Essa si manifesta tanto più forte
e rifiorente quanto più viene avvertita l’esigenza di reagire contro
l’irrigidirsi dell’esperienza monastica in forme convenzionali o il suo decadere
per la corruzione dei costumi e la perdita dei primitivi ideali. Nella
tradizione cristiana sono innumerevoli i sostenitori dell’una forma contro
l’altra. I fautori della vita cenobitica sottolineano i rischi della solitudine,
gli eccessi dell’orgoglio e del fanatismo ascetico ai quali
essa può condurre; gli altri allertano sulla pigrizia
spirituale e lo smarrimento di ogni ideale tensione che facilmente si originano
dalle troppe comodità e mediocrità della condizione cenobitica. In effetti è
accaduto spesso che le effervescenze carismatiche del monachesimo
trovassero sbocco in iniziative di tipo anacoretico, e che proprio quei monaci
che si sentivano investiti di una speciale missione e perciò bisognosi di
libertà e mobilità lasciassero il convento e scegliessero forme di vita
solitaria.
Nella storia religiosa dell’Europa ci sono stati
momenti nei quali l’inquietudine sociale e l’ansia di rinnovamento spirituale
hanno fatto dell’eremitismo una vera e propria alternativa al cenobitismo. Uno
di essi è rappresentato dai secoli XI-XII, quando alla crisi dell’economia
feudale e al rifiorire di quella cittadina si accompagnò, assieme alle sempre
più pressanti istanze di riforme religiose e di ritorno all’evangelismo
monastico, la crisi della forma cenobitica. L’esistenza di solitari che si sono
allontanati dalla famiglia o dal cenobio, talvolta dal clero secolare, per
vivere nei boschi viene segnalata in tutto l’alto Medioevo. All’inizio del V
secolo nel nascente cenobio di Lérins, come testimonia Eucherio nel suo
Elogio dell'eremo,
abitavano in disparte dalla comunità i solitari che volevano vivere secondo i
costumi degli
Aegyptii
patres. Nel secolo successivo la comunità fondata da Cassiodoro a
Squillace prevedeva nella parte più alta del colle sul quale sorgeva il cenobio
un sito riservato agli eremiti. Nel secolo XI e, più ancora, nel XII, il
fenomeno dilaga. Nelle Fiandre e nella Francia le masse popolari sono infiammate
dalla predicazione degli ‘uomini santi’, che indossano tuniche di pelle, si
nutrono di erbe e di radici, e predicano la fuga dal mondo come unico rimedio
all’oppressione dei poteri politici e alla corruzione di quelli ecclesiastici.
L’Italia ha avuto grandi figure di eremiti, come il
ravennate san Romualdo (m. 1027), il quale, dopo anni passati in convento, a
Ravenna e a Cuxà, sui Pirenei, deluso dell’allentata disciplina cenobitica,
rinunziò alla carica di abate e andò peregrinando per l’Italia centrale, nelle
Marche e in Romagna. O come Bruno, nato a Colonia e per anni maestro nella
scuola di Reims, il quale nel 1084 fondò un eremo destinato a grande sviluppo
nella valle della Chartreuse, vicino Grenoble, e pochi anni dopo, nel 1091, si
ritirò sulle Serre calabresi, nelle estreme propaggini meridionali
dell’Appennino, a cavallo tra Ionio e Tirreno. Anche san Francesco previde per i
suoi confratelli la possibilità di condurre vita eremitica e compilò per loro
una rapida raccolta di norme,
De religiosa habitatione in eremo.
I modelli orientali,
mai dimenticati, esercitano attrazione crescente. Come al tempo degli antichi
eroi del deserto, anche ora gli eremiti più venerati sono quelli nei quali
appaiono più marcate la spiritualità del penitente e le rinunzie dell’asceta.
Più ancora dell’antico, questo nuovo eremitismo è contrassegnato da forme
radicali di deprezzamento delle realtà terrestri, da una visione teocentrica del
mondo che si traduce in escatologismo apocalittico, da un ascetismo spinto fino
alla sordidezza e alla mortificazione umiliante. Tuttavia, assai spesso accade
che questi convintissimi zelatori della vita ascetica e contemplativa si
preoccupino dell’altrui oltre che della propria salvezza, conducano vita di
attivo apostolato soccorrendo i viaggiatori, i poveri, i reclusi, si spostino in
paesi anche lontani per predicare: sarà un eremita, è noto a tutti, a bandire la
prima Crociata.
Per queste ragioni non raramente nell’esperienza
eremitica il momento individuale ha breve durata. Quanto più appare santo e
venerabile, tanto più l’asceta solitario attira devoti e aspiranti, li riunisce
attorno a sé, dà vita a una nuova fondazione monastica, riconduce, cioè, a forme
di vita cenobitica. Fondazioni eremitiche come quelle di Camaldoli e di
Vallombrosa associano forme di eremitismo e cenobitismo e nuovamente, come a
Lérins o a Squillace, prevedono la compresenza di monaci
che dimorano e lavorano insieme e di solitari che vivono in una completa
segregazione, interrotta solo dall’obbligo
di consumare i pasti in comune. Camaldoli, nei pressi di Arezzo, fu installata
da san Romualdo, che fondò o
riformò numerose altre comunità, nelle quali volle che fosse prevalente
su quella cenobitica la struttura eremitica, al punto da stabilire che l’unico
superiore della comunità risiedesse fra gli eremiti, non nel cenobio.
Vallombrosa, nel comune di Reggello presso Firenze, fu fondata dal fiorentino
Giovanni Gualberto (m. 1073), anch’egli pellegrino dopo anni di deludente vita
cenobitica e anch’egli fattosi fondatore di nuove comunità con il progetto di
ritornare alla spiritualità e ai costumi degli antichi solitari.
Una fondazione eremitica che si è tramutata in un vero
e proprio Ordine monastico, quello dei Certosini, e che ha segnato per secoli la
storia del
monachesimo europeo, fu la Chartreuse
fondata da san Bruno, nella quale sia il fondatore sia i suoi successori
cercarono di tutelare le esigenze di solitudine e libertà spirituale proprie
dell’opzione eremitica, pur mantenendo i princìpi fondamentali della
koinonìa cenobitica,
cioè la stabilità del monaco e la sua piena sottomissione all’autorità del
priore. Il monaco certosino dispone di una cella individuale, nella quale resta
chiuso l’intera giornata; in essa legge, prega, medita, e non ne esce neppure ai
pasti, ma solo per l’ufficio divino. Non era soltanto una modificazione delle
strutture abitative del cenobio, volta a realizzare il passaggio dal dormitorio
comune e dal grande refettorio alla celletta
singola, ma una grande riforma del costume monastico, orientata alla riconquista
di una religiosità personale e fondata sul concetto che importanti fossero,
nella via della salvezza, non l’osservanza delle liturgie e la pratica rituale,
ma il colloquio e il contatto spirituale con il divino.
Anche nei secoli successivi, nel XIV e nell’età
rinascimentale, l’eremitismo si mantenne vivace in tutto l’Occidente, dove si
moltiplicarono i piccoli eremi, disseminati nelle foreste, sulle montagne, nelle
isole. Fiorirono numerosi in Spagna, nella Navarra, nella Catalogna a Montserrat,
dove si ritirerà ai tempi della conversione Ignazio di Loyola. Scompariranno,
invece, a partire dal secolo XVI nelle regioni passate al protestantesimo. Ma
anche altrove contro la vocazione eremitica congiureranno le istanze proprie
della società moderna e della civiltà industriale, il razionalismo e il
pragmatismo, il legalismo giuridico, i nuovi assetti del territorio. Senza
dimenticare la sfiducia della stessa Chiesa, che all’eremitismo ha guardato
sempre con sospetto. Fin dall’antichità i concili provinciali intervennero per
limitare e controllare la libertà degli eremiti e, quando non la vietarono, le
opposero cautele e impedimenti vari. Ai monaci non fu permesso di ritirarsi in
un eremo se non dopo avere vissuto per anni nella comunità; il permesso fu in
genere accordato solo ai monaci di provata virtù e di età avanzata («giovane
monaco, vecchio diavolo», recitava un adagio popolare); anche gli eremiti
restavano sotto la giurisdizione dell’abate. Quando l’aspirante alla vita
solitaria era un laico, la legislazione canonica gli imponeva di chiedere
l’autorizzazione al vescovo della diocesi, la quale gli conferiva una sorta di
tutela ecclesiastica. Senza di essa l’eremita restava sottomesso alla
giurisdizione civile, tendente a considerarlo uno sbandato e un asociale. Non
raramente i vescovi si rifiutavano di ammettere eremiti nelle loro diocesi. Più
volte, nei momenti di più vivace efflorescenza, sono intervenuti i papi. Nel
1256 Alessandro VI riunì un gran numero di piccoli gruppi di carattere eremitico
nell’Ordine degli Eremiti di sant’Agostino, che si diffuse in tutta l’Europa ma
andò cancellando rapidamente gli originari caratteri eremitici dei gruppi. Nel
1748 il papa Benedetto XIV dedicava agli eremiti un capitolo del rinnovato
trattato di diritto canonico, riorganizzando sotto il controllo rigoroso
dell’autorità ecclesiastica i gruppi esistenti, ma senza prevedere l’eventualità
di nuove aggregazioni. Il
Corpus canonico del 1917 considera e regolamenta solo
le forme comunitarie della vita religiosa, mentre vi sono ignorati ed esclusi
gli eremiti.
Anche per questo, per anni l’eremitismo è sembrato
definitivamente scomparso dalla scena religiosa dell’Occidente, e solo negli
ultimi tempi, dopo il concilio Vaticano II, ha dato segni di risveglio. I
canonisti gli hanno ridato attenzione, ma il riconoscimento ecclesiastico si è
risolto solo in una particolare forma di esclaustrazione,
ad nutum Sanctae Sedis,
cioè nel permesso, accordato dall’autorità ecclesiastica per un tempo limitato,
di lasciare il cenobio e vivere in segregazione.
3.
Il cenobitismo
Interrotta, come abbiamo visto, da periodi di forti
rinascenze anacoretiche, è costante nella storia del
monachesimo
la tendenza ad accentuare le forme comunitarie a spese degli spazi di libertà
individuale. La compressione dell’individuo dentro il
comportamento regolare è il fondamento della vita
cenobitica. L’asceta è
custos sui
ipsius e per sua vocazione tende a concentrarsi sulla sua
personale salvezza, ma accetta l’onere della vita in comune per evitare pericoli
e rigori che la solitudine può causargli in misura superiore alle sue forze. In
ogni religione i legislatori più saggi sono stati quelli che hanno curato
l’equilibrio delle due esigenze; l’eccesso patologico si è avuto con le
legislazioni che hanno preteso di immischiarsi nei più minuti dettagli della
condizione monastica e hanno condotto alla sclerosi conformista. Il
monachesimo buddista e quello cristiano hanno corso
spesso questo rischio, il secondo più del primo. Soprattutto nel Tibet, ma
ovunque si sia ‘clericalizzato’, il buddismo ha elaborato regole minuziose per i
suoi monaci, impigliandosi specialmente nella difficoltà di trovare l’equilibrio
fra la tendenza speculativa e quella pratica. Questa difficoltà è stata forte
anche nei monasteri cristiani, particolarmente quando, nel periodo della
Scolastica, i religiosi si accostarono in gran numero alla pratica delle scienze
e delle arti; ma in essi gli eccessi hanno riguardato soprattutto l’esercizio di
un’autorità soffocante, che tendeva a privare il monaco di ogni margine di
autonomia.
Sogliono essere considerati tre gli elementi generali e
immancabili che caratterizzano la condizione cenobitica: il monastero, nel quale
la comunità abbia residenza stabile, la regola, che ne costituisce la legge,
l’abate che la governa e ammaestra. Non sempre, tuttavia, questi tre elementi
sono compresenti con la medesima efficacia e interagiscono allo stesso modo.
Essi appaiono saldamente costituiti nel primo esperimento storicamente certo,
quello di Pacomio (m. 347), il quale diede alle sue fondazioni, a Tabennesi
nell’Alto Egitto, una struttura rigorosa, che spesso è stata definita ‘militare’
e ritenuta proveniente dal suo passato di soldato. I suoi monasteri accoglievano
un gran numero di persone, divise in gruppi di trenta o quaranta a seconda dei
mestieri praticati (giardinieri, panettieri, cestai, ecc.). I manufatti prodotti
servivano in parte all’uso interno, in parte venivano venduti lungo il Nilo,
fino ad Alessandria. I monasteri erano raggruppati in strutture non
dissimili da un vero e proprio villaggio, e in ciascuno all’organizzazione del
lavoro e alla preghiera in comune sovrintendeva un superiore. Tutti erano
sottoposti all’autorità di un superiore generale (il primo fu Pacomio), che
visitava con frequenza i monasteri e ne riceveva i capi una volta l’anno, in
agosto, per averne il rendiconto.
Una gerarchia meno articolata e una disciplina meno
rigorosa erano invece previste da Basilio (m. 379), ritiratosi per anni in un
monastero fondato in una sua proprietà, ad Annesi sul Ponto, e poi diventato
vescovo di Cesarea. Dopo averne preso conoscenza diretta nel corso dei suoi
viaggi in Egitto, egli non risparmiò le sue critiche al modello pacomiano, del
quale rifiutò l’autoritarismo che improntava i rapporti fra l’abate e i suoi
monaci e il ruolo prioritario assegnato al lavoro a scapito della vita
contemplativa. Il monastero da lui disegnato ha dimensioni ridotte, si ispira
più alla immagine della famiglia che a quella dell’opificio, l’organizzazione
della comunità è fondata sul principio della fratellanza e del mutuo soccorso
tra fratelli, il superiore è padre e direttore delle coscienze e tempera la sua
autorità consultandosi con i fratelli.
Ancora meno perentori appaiono i requisiti ‘pacomiani’
nel primo cenobitismo occidentale, anche se esso guardò sempre ai modelli
orientali e, in particolare, a Pacomio. In realtà, dai suoi primi protagonisti
quella dei monaci non fu concepita come una condizione particolare e sottoposta
a norme specifiche, né gli uni si distinsero dagli altri in virtù di una
‘regola’ diversa. Il termine stesso,
regula, soltanto tardi, lungo il VI secolo, acquistò
il significato tecnico con il quale venne da allora riferito alle realtà
monastiche, cioè di un codice legislativo scritto. Costantemente, nella prima
letteratura monastica in lingua latina, sembra di avvertire una pronunciata
riluttanza ad accettare l’idea del legislatore dal quale attendere norme e
precetti, e una più diffusa tendenza a esigere da lui garanzie soprannaturali.
Secondo san Gerolamo, Pacomio e i suoi discepoli legiferarono «secondo
l’insegnamento di Dio e dell’angelo che Dio aveva loro mandato»; nel prologo
della
Regola dei
quattro Padri i legislatori invocano lo Spirito Santo perché li
ispiri mentre si apprestano a redigere l’ordinamento della comunità, e più
volte, nel corso della stesura, invocano l’assistenza di Dio e si presentano
come interpreti della sua ispirazione. Il lerinese Eucherio insegna che
nell’eremo non operano le leggi dell’uomo, ma quelle eterne di Dio, e che sono i
carismi concessi al luogo stesso dell’asceterio ad assicurare al monaco la
santità, mentre ogni norma conformata alle leggi umane nuoce al realizzarsi
dell’uomo interiore.
Norma suprema del monaco, unica e vera ‘regola’ della
sua vita è la Sacra Scrittura. Secondo il racconto del suo biografo, Agostino,
nel costituire il monastero di Ippona, non gli assegnò altra regola che quella
degli apostoli e quando, più tardi,
lo
abbandonò per ricoprire la dignità vescovile, concepì la raccolta di
precetti lasciata ai suoi monaci non come una legge ma come un
libellus,
nel quale essi, leggendolo, potessero guardare se stessi come in uno specchio:
uno specchio nel quale, immancabilmente e continuamente, si rifrange la parola
divina.
La Bibbia e la tradizione: sono queste le due fonti
alle quali il monaco deve attingere i modelli supremi della sua condotta. Nel
capitolo finale Benedetto si chiede «quale pagina o parola di autorità divina
del Vecchio e Nuovo Testamento sia la norma più retta per la vita dell’uomo,
rectissima norma vitae humanae»,
e rinvia coloro che vogliono pervenire alla perfezione della vita monastica agli
autori passati, a Cassiano, a Basilio, alle
Vite dei Padri,
mentre definisce il suo testo una «regola minima, scritta per i principianti».
Dopo di lui, un ignoto legislatore italiano, autore di una così detta
Regola di Paolo e Stefano,
ribadisce che non la sua regola, ma gli esempi degli antichi Padri offrono il
vero e pieno insegnamento della perfetta disciplina monastica.
Tuttavia l’istituto monastico si è andato trasformando.
Dopo Agostino e le
Regulae Sanctorum Patrum lo strumento legislativo è
cresciuto, si è perfezionato, si è imposto. Ai monaci i veri monaci, cioè i
cenobiti non si prescrive soltanto, come nella
Regola dei quattro Padri,
che vivano concordi nella medesima dimora, ubbidienti alle disposizioni e ai
consigli di un superiore, ma si impone una duplice autorità, della regola e
dell’abate, prima di quella, poi di questo. Il cenobita è detto nel primo
capitolo della regola del Maestro e di quella di Benedetto è colui che vive nel
monastero e «milita sotto la regola e sotto l’abate»,
sub regula vel abbate.
Né la sua dimora può essere temporanea e variare a suo piacimento. Il principio
della stabilità diventa ora ineludibile. Anche Gerolamo, Rufino, Cassiano, che
pure erano stati essi stessi, in taluni periodi della loro esistenza,
peregrini, lo
avevano propugnato fermamente. Cassiano indicava tra le pratiche esemplari dei
maestri egiziani la perseveranza dei vecchi asceti, stabili nei loro monasteri
fino a quando gli anni li rendevano curvi,
usque ad incurvam sene et am, ammirevoli per avere
saputo resistere per lunghi anni al disgusto generato dalla monotona permanenza
nella chiusa angustia del convento. La
Regola dei quattro Padri consentiva di ricevere i
monaci provenienti da un altro monastero solo se avessero avuto dal proprio
abate il permesso scritto di trasferirsi, e stabiliva che nel nuovo cenobio essi
fossero considerati ultimi per anzianità e non contassero nulla gli anni passati
nel vecchio.
Con l’azione normalizzatrice delle regole e il loro
precisarsi e arricchirsi cresceva di pari passo l’autorità dell’abate e si
rinsaldavano i suoi strumenti di governo. Nelle antiche comunità, spesso sorte
per l’iniziativa di un singolo, attorno al quale si raccoglieva un primo nucleo
di discepoli e ammiratori, erano l’esempio e le virtù del fondatore a reggere il
cenobio, non la norma scritta. L’immagine del superiore come padre illuminato e
misericordioso sopravviverà nella tradizione agiografica e, in qualche misura,
anche nelle regole, le quali avranno tutte, più o meno lungo e puntuale, un
capitolo
sul direttorio abbaziale, che disegnerà
il ritratto del buon abate attribuendogli le qualità tradizionali. Ma le più
antiche stenteranno ad assegnargli un potere ben definito e i necessari
strumenti autoritativi. Per Basilio il superiore cura i fratelli come un padre o
un medico o «come una nutrice i suoi piccoli»; nella tradizione agostiniana il
superiore è un padre al quale si deve obbedienza e rispetto e al quale spetta
correggere gli erranti, ma più con la carità, con l’esempio, con la pazienza e
la parola consolatrice che con l’imposizione.
Nel Maestro e in Benedetto la figura e il ruolo
dell’abate trovano una dimensione nuova. Custode della regola e responsabile
della sua costante applicazione, l’abate adempie al suo compito nel monastero
come delegato e rappresentante di Cristo; egli ascolta il consiglio dei
fratelli, ma in definitiva la sua decisione è sovrana, il suo potere si dispiega
con nuova efficacia, sostenuto da una normativa penale diventata ricca e sicura.
E anche severa. Senza la durezza inflessibile della regola di Colombano, che
ricorre continuamente alla
vindicta corporalis, il Maestro e Benedetto
affrontano con cura il tema delle misure punitive e recuperano l’antica severità
egiziana, con i suoi due principali strumenti repressivi, l’esclusione e le
percosse. Importato nel cenobio dalla scuola di retorica e dal servizio
militare, l’uso della ferula viene legittimato con il ricorso alla Scrittura
(viene citato il versetto di
Proverbi 19,29: «Lo stolto non si corregge con le
parole») e imposto all’abate come uno strumento inevitabile. Sferza e bastone
nella prassi dovettero essere impiegati senza risparmio, se la tradizione
iconografica ha amato rappresentare l’abate benedettino, e lo stesso Benedetto,
con la sferza tra le mani. Senza dubbio non mancarono periodi ed emergenze in
cui l’abate vide
il
suo potere diminuito o condizionato. Nella stessa regola benedettina si
avvertono situazioni nuove di tensione e si intravedono stati di necessità che
la
Regula Magistri
ignora; l’accresciuta attenzione per i rapporti all’interno della comunità
appare dovuta non solo allo spirito pragmatico del legislatore, ma anche a una
condizione generale di più allentata pressione gerarchica. Ma l’abate concepito
da Benedetto, responsabile di fronte a Dio del progresso spirituale dei suoi
monaci e perciò da Dio stesso delegato, misericordioso con i fratelli, ma unico
a distribuire con volontà sovrana compiti e incombenze, unico a premiare e
castigare, ad accogliere e rifiutare, governerà per secoli i monasteri europei.
Anche nei rapporti con la Chiesa il distacco dalla
quale era tra le ragioni fondanti del
monachesimo
l’autorità dell’abate ebbe vicende alterne. Le regole antiche mantengono,
espresso con varia fermezza, il rifiuto del clero e della sua ingerenza nella
vita del cenobio. Nel primo monachesimo
occidentale è frequente il caso di monaci elevati all’episcopato (nel monastero
martiniano di Tours, nei monasteri di Agostino, a Lérins); è raro il caso
opposto, di chierici che si fanno monaci, poiché i cenobi riluttano ad aprirsi
al prete, anche quando la celebrazione dell’eucarestia stabilizza la necessità
di farvi ricorso. La
Regola dei
quattro Padri impone di ricevere i preti con grande rispetto, come
si conviene a chi amministra i servizi dell’altare, ma non consente che un
chierico abiti nel monastero, a meno che voglia mondarsi, con la medicina
dell’umiltà, di una grave colpa. La stessa preclusione troviamo nel Maestro, che
ammette i sacerdoti solo come forestieri,
peregrinorum loco, e li esclude dal governo del
cenobio. Benedetto ammette che i chierici che lo desiderino entrino a far parte
della comunità, ma il suo atteggiamento è forse ancora più difensivo di quello
del Maestro. I preti avranno un posto speciale soltanto nelle cerimonie
liturgiche, per il resto avranno il posto che compete a essi per anzianità e
saranno assoggettati in tutto alle norme della regola e all’autorità dell’abate.
Il tema dei rapporti
tra monaci e chierici si affaccia in alcuni documenti pontifici, ma senza che
venga affrontata la questione giurisdizionale: in nessuno di essi si legge una
sola espressione che riconosca ai vescovi la facoltà di intervenire nella vita
dei monasteri. Neanche in Africa, dove Agostino ha inaugurato una tradizione di
stretta dipendenza delle comunità cenobitiche dalla gerarchia, troviamo
teorizzata o applicata una coerente linea giuridica e istituzionale; qui come
altrove i rapporti tra i vescovi e i monasteri restano legati al
pactum iniziale e
all’origine del monastero e affidati all’iniziativa del vescovo, alla
remissività dell’abate, al peso inerte della tradizione. Negli atti sinodali le
questioni concernenti monaci e anacoreti non trovarono posto frequente. Fu un
concilio tenuto ad Arles intorno alla metà del V secolo ad affrontare, primo tra
i concili gallici, questioni monastiche e a prospettare il problema dei rapporti
tra la Chiesa e i cenobi, dell’autonomia di questi rispetto a quella. Il
deliberato conclusivo del concilio risolveva il problema giurisdizionale
distinguendo con precisione le prerogative del vescovo e quelle dell’abate.
Riservava al primo il diritto di ordinare chierici e ministri dell’altare, di
inviare la cresima e confermare i neofiti; vietava al monastero di ammettere
preti e stabilire le loro funzioni senza l’assenso del vescovo. Per contro, il
governo della comunità monastica, definita
congregano laica, restava affidato unicamente
all’abate, al vescovo si negava la facoltà di rivendicare alcunché che
appartenesse al monastero o di attrarre nelle file del clero alcuno dei monaci
se non fosse stato l’abate stesso a farne richiesta. I concili successivi non
aggiungono molto in fatto di rapporti tra le autorità ecclesiastiche e i
monasteri, ma gli spazi dell’autonomia monastica si riducono progressivamente.
In un concilio svoltosi in una data imprecisabile, tra il 481 e il 491, si
confermerà il diritto dell’abate di accordare ai monaci il permesso di vivere
fuori del cenobio, in celle separate, senza richiedere l’autorizzazione del
vescovo. Il divieto per il vescovo di ordinare prete un monaco senza il consenso
dell’abate sarà sancito ancora nel concilio di Agde, nel 506. Ma nello stesso
concilio è previsto che le nuove fondazioni monastiche siano autorizzate dal
vescovo e che i monaci
peregrini
siano forniti di lettere commendatizie rilasciate dal vescovo. Il concilio di
Orleans del 511 rafforza ulteriormente l’autorità dei vescovi e il loro
controllo
sui monasteri e i loro abati, i quali si dichiara definitivamente e
ufficialmente sono sottoposti all’autorità episcopale,
in
episcoporum potestate consistunt.
4. Le classi sociali
Se le due forme principali della condizione monastica
sono quelle che discendono dall’alternativa fra eremo e cenobio, un’importanza
enorme nella storia del cenobitismo, dei suoi costumi, delle sue ‘forme’, hanno
avuto le distinzioni sociali, il
loro riprodursi all’interno del cenobio, il loro ruolo
nei rapporti degli istituti monastici coll’esterno, con gli altri istituti della
società. Nell’immaginario collettivo la figura del monaco è solitamente
associata alla povertà e all’umiltà. Ma in tutte le latitudini il
monachesimo ha storie di ricchezza e di potenza. Più
che mai il monachesimo cristiano. Di esso si è
fatto spesso, alle origini, un movimento rurale di poveri e rozzi contadini. Ma
a dissuaderci da una tale convinzione basterebbe forse considerare una legge
romana di età imperiale, conservata nel
Codice
Teodosiano (XII 1, 63), la quale ingiungeva che ritornassero ai
doveri curiali o rinunciassero ai loro beni quegli appartenenti alle
élites municipali
che avessero lasciato le municipalità per entrare nei monasteri. Il decreto fu
emanato nel 370, una data troppo alta perché si possa pensare che le preoccupazioni
del governo imperiale riguardassero l’Occidente, dove
il richiamo monastico cominciava appena a farsi sentire. Nell’Oriente, invece,
che a quella data registrava già molte e popolose comunità monastiche, la legge
indica che in quelle comunità le classi possidenti avevano parte considerevole.
Anche riguardo al contesto più spesso portato ad
esempio, quello copto dell’Egitto tardoantico, gli studi più recenti tendono a
rivedere l’immagine tradizionale, che ne faceva protagonisti i contadini più
poveri, i
fellahin, e a
rivalutare il ruolo che vi ebbero le classi agiate e l’entità della loro
presenza. Di non pochi tra i personaggi di cui ci è stata tramandata notizia
sappiamo che provenivano da famiglie di ricca condizione: a cominciare dallo
stesso «Padre dei monaci», l’eremita Antonio, il quale, al momento di
abbandonare il secolo, si trovò a dovere liquidare il suo patrimonio,
lasciandone una parte alla sorella e dividendo il resto ai poveri. E significativo
che siano stati gli ambienti monastici a fornire sempre più spesso i vescovi
delle diocesi egiziane. Anche assai presto. Dalle comunità pacomiane provengono
i vescovi Philn e Muis, il primo chiamato alla cattedra vescovile di Tebe nel
339, il secondo, vescovo di Latopolis nel 347, come attesta una lettera di
Atanasio. E se i vescovi non potevano non essere forniti di un notevole grado di
cultura e quindi non appartenere alla classe dei colti e dei ricchi, anche tra i
monaci l’alfabetizzazione era meno rara di quanto si ritiene, mentre appartiene
alla letteratura fortemente ideologizzata e agiografica il modello del santo
illetterato, ostile alla cultura profana. La costruzione delle laure, strutture
semianacoretiche nelle quali non di rado i modelli abitativi e gli stili di vita
riflettevano quelli delle classi agiate, impegnava somme considerevoli di
denaro. Le comunità pacomiane, che si è soliti catalogare come insediamenti
tipici del deserto, talvolta erano vicine alla città, nel suburbio o addirittura
dentro (come ad Alessandria), e con la città intrattenevano rapporti economici
continui, gestiti è ovvio supporre da persone esperte e acculturate. Né, infine,
si può trascurare il fatto che le istanze ascetiche presenti alle origini del
monachesimo erano troppo complesse e
culturalmente persino elitarie per consentirci di attribuirle alle classi
sociali più basse e incolte.
Ancora più considerevole fu il concorso delle classi
medioalte nell’Occidente. A famiglie agiate appartenevano personaggi come san
Gerolamo, venuto a studiare a Roma dalla provincia dalmata presso maestri
insigni e costosi, e come Bonoso, Rufino ed Eliodoro, che gli furono compagni
prima negli studi, poi nelle iniziali esperienze di vita monastica. Grandi
casate romane diedero ospitalità ad Atanasio, esule con altri preti e
probabilmente anche con monaci intorno al 340, e ne ascoltarono la predicazione
ascetica. Più tardi, dopo il 380, sotto il pontificato di Damaso, l’aristocrazia
romana, specialmente quella femminile, si lasciò conquistare dagli infiammati
discorsi di Gerolamo; ricche vedove e nobili vergini dedite all’ascesi compaiono
con frequenza negli epistolari di Ambrogio, Paolino di Nola, Sulpicio Severo,
Gerolamo, Pelagio, Agostino, o ancora nel VI secolo, nelle lettere di Fulgenzio.
Un episodio di clamorosa risonanza fu la velazione della giovane Demetriade,
accompagnata dal plauso e dai consigli dei tre più ascoltati maestri del tempo,
Agostino, Gerolamo e Pelagio.
Questi casi ebbero grande rilevanza nella società del
tempo e giunsero a costituire una vera e propria questione sociale, perché
queste appartenenti alle famiglie più illustri dell’Impero, gli Anici, gli
Aradii, i Pammachii, ora davano scandalo, lasciavano le famiglie, si ritiravano
a vivere da sole o in piccoli gruppi e scandalo maggiore di ogni altro rompevano
l’asse patrimoniale vendendo o alienando le loro ricchezze a favore dei poveri.
Volgendo a forme nuove di patronato l’antico evergetismo romano, esse
assicurarono sviluppo e strutture originali al
monachesimo
femminile. Furono le grandi risorse patrimoniali e l’impegno personale delle sue
nobili e ricche amiche a consentire a Gerolamo, trasferitosi in Palestina, a
Betlem, dopo il 385, di dare vita a più monasteri. Terasia, la moglie di Paolino
di Nola, accompagnò il marito nel ritiro ascetico e contribuì con parte del suo
patrimonio alla costruzione di Cimitile; Melania la Vecchia seguì Rufino in
Egitto, si schierò con lui contro Gerolamo nell’aspra controversia su Origene,
fondò un monastero femminile a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, sovvenzionò
gli asceteri nascenti nelle isolette del
Mediterraneo, fu tra i fautori di Pelagio nello scontro con Agostino.
Nell’Italia di Teoderico l’africano Fulgenzio ebbe tra i suoi interlocutori
vergini consacrate di alta nobiltà, come Proba,
forse figlia di Quinto Aurelio Simmaco e perciò imparentata con Cassiodoro e
Boezio.
La
sorella di Cesario fu badessa di un monastero ad Arles e a lei Cesario
indirizzò la sua
Regula virginum. In
quegli anni Rusticola, protagonista di una delle più celebrate
Vite merovingie, fu
badessa per più di mezzo secolo (574-632) del più noto monastero femminile di
Poitiers; a Poitiers fu relegata Radegonda, regina ripudiata e personaggio
tragico nell’epoca sanguigna e turbinosa dei primi re
franchi (di lei diremo ancora in seguito).
Non sembra, dunque, eccessivo ritenere che l’ascetismo
femminile occidentale sia stato
in
misura considerevole un fenomeno
aristocratico. Probabilmente distinzioni e gerarchie sociali presero a definirsi
all’interno delle comunità fin dai primi tempi. Nel popoloso monastero femminile
fondato a Betlem da Paola, la più devota e munifica delle amiche di Gerolamo,
«le numerose fanciulle, sia nobili che di media e infima estrazione, furono
divise in tre gruppi». Rispettandone la provenienza sociale? E’
probabile. Non lo attesta con tutta evidenza il passo dell’elogio funebre
scritto da Gerolamo in memoria dell’amica nel 404. Ne emerge, tuttavia, il
rilievo dato al ceto d’origine, la distinzione che esso continuava a segnare
all’interno della comunità, nonostante il continuo riconoscimento tributato
all’umiltà della nobile defunta e delle sue compagne. Siamo ai primi, lontani
segni di un processo che sarebbe sfociato nell’esclusivismo nobiliare e nelle
strutture selettive e discriminanti impostesi per secoli, nei conventi femminili
ancora più vistosamente che in quelli maschili. Nei monasteri dell’America
spagnola venivano normalmente a costituirsi tre classi, poiché le figlie degli
hidalgos
destinate alla monacazione entravano in convento accompagnate da
una conversa, bianca, e da una schiava, negra o indiana, che restavano al loro
servizio e dovevano a esse obbedienza assoluta.
In alcuni Ordini per ogni monaca di ceto superiore erano previste una cucina
privata e una
hermana de obediencia,
una «suora di servizio» che la gestiva.
Considerevoli presenze di elementi aristocratici si
registrano con frequenza anche nelle iniziative maschili e nelle prime
fondazioni di comunità monastiche. In una lettera del 397 Gerolamo attesta che a
Roma erano numerosi i monaci «colti, ricchi e nobili». Gli asceti occidentali
che Palladio incontra pellegrini in Oriente e dei quali ci dà notizia nella sua
Storia
Lausiaca sono patrizi di casato illustre e di opulente fortune.
Nell’Africa latina, nel monastero di Ippona Agostino attira elementi delle
classi elevate e della burocrazia imperiale, molti dei quali finiscono vescovi
delle principali città della Numidia. Tra gli spagnoli al seguito
dell’imperatore Teodosio vi sono funzionari di attiva fede cristiana, che poi
ritroviamo legati a iniziative ascetiche sia orientali che occidentali.
L’episodio più clamoroso di ogni altro fu quello di
Paolino, ricchissimo senatore dell’Aquitania, che al culmine di una rapida
carriera (consul
suffectus e governatore della Campania a meno di trent’anni),
intorno al 390, si spogliò di gran parte dei suoi beni, si dedicò
con la moglie alla vita ascetica e, ritiratosi a Nola, nel 395, in uno dei suoi
possedimenti, vi fondò una comunità monastica. Il suo esempio fu seguito da
altri nobili aquitani, i cui nomi compaiono nelle sue lettere e in quelle di
Sulpicio Severo, un tolosano di grande famiglia, che in quegli stessi anni si
ritrasse a vita solitaria con la suocera Bassula e con un gruppo di pii amici in
una sua villa a Primuliacum, nella Narbonese Prima. Sulpicio fu il biografo di
Martino, vescovo di Tours e fondatore, dopo un primo esperimento a Ligugé, di un
monastero a Marmoutier, dove molti monaci erano nobili e parecchi tra loro
diventarono vescovi: «Quale città o chiesa scrive Sulpicio nella
Vita di san Martino
poteva non desiderare di avere un vescovo proveniente dal monastero di
Martino?».
Sotto questo aspetto la comunità della quale è
attestato con maggiore sicurezza e continuità il carattere aristocratico è
quella fondata nei primi anni del V secolo a Lérins, un isolotto sulla Costa
Azzurra tra Cannes e Antibes, da Onorato, poi vescovo di Arles, e rapidamente
popolata da personaggi di alta estrazione sociale. Si trattava, probabilmente e
almeno in parte, di funzionari della corte di Treviri e ricchi possidenti, in
fuga davanti ai Germani invasori dopo la rottura
del confine renano nel 406. Dall’asceterio
lerinese uscirono alcuni tra gli scrittori più rappresentativi del V secolo e
molti tra i vescovi più prestigiosi e attivi di quel secolo e del successivo,
chiamati a dirigere le diocesi della Gallia centro-meridionale:
une pépinière
d’évèques, come scrissero i benedettini dell’Histoire de la France.
Non restano elementi sufficienti per ricostruire di
volta in volta se e quanto le differenze sociali abbiano operato all’interno
delle antiche comunità monastiche. Sembra certo che anche nel chiostro gli
elementi di più elevata condizione finissero per assumere posizioni di
preminenza, non solo per il ruolo che la gerarchia sociale dell’epoca assicurava
al loro rango, ma anche perché il livello di cultura, la rete dei rapporti
sociali, le competenze amministrative, la consuetudine con le funzioni direttive
li destinava naturalmente all’organizzazione e alla guida del cenobio. E’
da ritenere che proprio la presenza di profughi di alta estrazione sociale, e
perciò di cultura superiore, di collaudata esperienza politica e amministrativa,
abbia avuto grande importanza sull’assetto della nascente comunità di Lérins,
sulla scelta dei modelli di vita e sull’elaborazione dei temi culturali. Anche
per queste ragioni Lérins, Marsiglia e le loro filiazioni maturarono caratteri
che le differenziarono profondamente da altri centri monastici della Gallia e di
altre regioni e promossero un tipo di ascetismo meglio organizzato, più colto,
meno aperto al folklore del miracoloso e del meraviglioso.
5.
I monasteri dei nobili
La figura dell’abate legato all’aristocrazia feudale e
alla corte, detentore di un formidabile potere economico e politico, appartiene
alle età successive, ma anche nei primi secoli le fondazioni nobiliari sono
frequenti. In Italia, alla fine del V secolo Eugippio e i suoi monaci
trasferirono dal Norico le spoglie di san Severino e si stabilirono nel
Castellum Lucullanum,
l’antica villa di Lucullo, sul promontorio di Miseno, che probabilmente ospitava
una comunità monastica quando vi era stato relegato Romolo Augustolo, ultimo
imperatore dell’Occidente. Dopo il 530 il patrizio Liberio, potente ministro dei
re goti, costituì un monastero ad Alatri; il generale bizantino Belisario fondò
e dotò un convento presso Orta, sulla via Flaminia. Tra il 556 e il 560 nacque a
Squillace, in Calabria, il
Vivarium a opera di Cassiodoro, il ricco e senatorio
ex ministro di Teoderico. Esso ospitò un attivo
scriptorium e una
cospicua biblioteca, si servì dell’opera di letterati, abili copisti, traduttori
dal greco, e se non fu il rifugio di nobili esuli ravennati o romani, come
talvolta si è preteso, fu verosimilmente un punto di raccolta e di riferimento
di profughi di vario tipo, di uomini stanchi del secolo, soverchiati dalle
difficoltà della società, minacciati dall’insicurezza dei tempi, attratti, come
da un rifugio di pace, da questo monastero fondato e sovvenzionato da un
patrizio di grande censo, aperto agli studi e al lavoro intellettuale.
Nei secoli successivi, specialmente la nuova nobiltà
formatasi nelle file dei Germani invasori, come tese a costituire rapporti di
potere con la gerarchia ecclesiastica, così non rinunciò a collocare suoi membri
in quella monastica, a fondare monasteri, dotarli e dirigerli. Ne derivarono
forme conventuali nuove: persino monasteri privati, di famiglia, appartenenti a
una casata, che li aveva costituiti su una terra di proprietà, esercitava su di
essi la sua protezione (tuitio,
commendatio), provvedeva al loro sostentamento e nel
contempo ne controllava l’amministrazione, e naturalmente riservava la direzione
e le cariche ai membri della
familia. Accanto ai monasteri di origine nobile, vi
furono «monasteri di nobili», nei quali cioè una parte dei monaci venivano
reclutati tra i nobili. Spesso si trattava di fanciulli, tra
i 5 e i 7 anni, «oblati», cioè offerti, per escluderli dalla successione
ereditaria ed evitare così il frazionamento del patrimonio familiare, o perché
bastardi, o ancora perché malati o deformi e perciò ritenuti inadatti a
ricoprire degnamente il loro posto nella società.
L’esclusivismo nobiliare imperò a lungo, per secoli e
quasi ovunque, a volte assumendo caratteri estremamente vistosi e generando
discriminazioni assolutamente incompatibili con le idealità monastiche. Tra i
conventi femminili era frequente la distinzione in case riservate alle nobili,
autonome e tutelate da vari privilegi, e case per le giovani di famiglia
borghese o plebea, sottomesse alla tutela ecclesiastica. Persino nella medesima
città, come a Brescia nel XII secolo, dove l’abbazia di Santa Giulia assumeva
solo le postulanti di condizione nobile, mentre quella dei Santi Cosma e
Damiano, soggetta al vescovo, riceveva tutte le altre. E famosa la pagina de
Le coté de Guermantes,
terzo volume della
Recherche
di Proust, nella quale la marchesa di Villeparisis sostiene che neanche le
figlie del re di Francia avevano ormai, da quando Enrico II ed Enrico IV avevano
contratto matrimonio con donne della famiglia dei Medici, i quarti di nobiltà
richiesti per essere accolte nei monasteri dei quali erano state badesse le
antiche prozie dei Guermantes.
Nelle grandi abbazie la differenziazione sociale fu
consuetudine perentoria e il ruolo privilegiato della nobiltà regolarmente
riconosciuto. Né alcune di esse, tra le più grandi e celebri della cristianità
medievale, sarebbero nate senza il concorso dei potenti signori feudali. Come
l’abbazia di Cluny, dalla quale si avviò un moto riformatore che coinvolse tutta
l’Europa e predicò il ritorno agli ideali del
monachesimo
primitivo, alla povertà, all’antica regola. Nell’atto di fondazione (nel 909 o
910) il munifico donatore stabilisce che nell’erigendo monastero dei santi
apostoli Pietro e Paolo vengano chiamati «i poveri di Cristo» perché vivano
secondo la regola di san Benedetto, nell’umiltà e nella preghiera, e dichiara
che il monastero e tutti i suoi beni saranno governati dall’abate, in assoluta
indipendenza dal potere secolare: «non soggetti al giogo nostro né dei nostri
parenti né di qualunque potestà terrena». Il secondo dei suoi abati, Oddone
(927-942) scriverà pagine di fuoco contro i privilegi del sangue, contro la
«pazzia» della nobiltà che opprime i poveri, e lotterà, fino a schiantarli,
contro gli appannaggi dell’antica abbazia di Fleury, protetta dal re di Francia.
Ma Oddone, come taluni dei suoi successori, era di famiglia comitale; il
fondatore, Guglielmo, era un potentissimo signore, duca di Aquitania e conte di
Macôn, titolare di immensi domìni, dalla Spagna
alla Borgogna; la
villa da lui donata era una proprietà fondiaria di
tipo carolingio, con la parte
dominica, riservata al signore e alla sua corte, e la
cappella, destinata all’adempimento degli obblighi religiosi della
familia; era
organizzata in mansi gestiti da servi e contadini tenuti alla più assoluta
obbedienza e a cedere una parte del raccolto; garanti della sussistenza e della
sicurezza dell’abbazia furono le più illustri famiglie della Provenza e della
Borgogna. Nel secolo XII la benedettina tedesca Ildegarda di Bingen, badessa
severa nel mantenere nella propria comunità le differenze sociali e autrice di
scritti oggi celebratissimi, avrebbe sostenuto che erano gli angeli e la loro
gerarchia a indicare il modello del cenobio e della diversità in esso
necessaria, e che il rispetto della diversità si traduceva per le sue monache
nell’esercizio congiunto di umiltà e carità.
I pericoli di
secolarizzazione di tali procedure e lo snaturamento delle finalità religiose
che esse comportavano furono sempre presenti ai legislatori. La regola
benedettina sottolinea che nel monastero tutti sono eguali, sia schiavi che
liberi, tutti soldati del Signore, allo stesso modo (cap. 2,20); e sempre,
quando più vivi si faranno i moti riformatori, ci si appellerà allo spirito
egualitario di Benedetto. Coi nuovi Ordini e le
riforme, dal secolo XII in poi, l’opposizione diventò più viva e a volte si
tradusse in veri e propri movimenti contestativi. Furono contestati
l’autoritarismo naturalmente connaturato al privilegio nobiliare, l’automatica
attribuzione del superiorato ai nobili, e tutti gli inconvenienti della
discriminazione nel concreto della prassi conventuale, ma anche il principio che
legava in permanenza la struttura religiosa allo stato sociale. Si diffuse
anche, e fu per secoli continuamente rifiorente, una letteratura che dissertava
sulla vera nobiltà, quella dell’animo e delle virtù, non del sangue.
| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |
| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |
20 giugno 2015
a cura
di
Alberto "da Cormano" ![]() alberto@ora-et-labora.net
alberto@ora-et-labora.net